Enrico
VIII
L’INGHILTERRA
DAI TUDOR
AGLI STUART
MICHELE E. PUGLIA
PARTE PRIMA
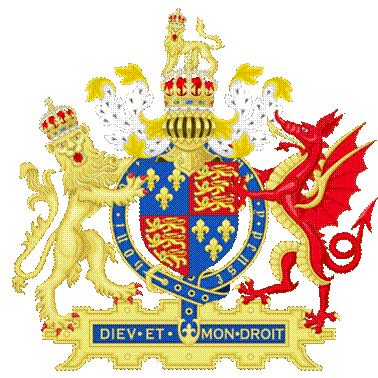
SOMMARIO: LA
PROCLAMAZIONE DI ENRICO VII E LA SANGUINOSA COMMEDIA DELLA
RIVOLTA IRLANDESE DI RICHARD SYMMONS; IL DIRITTO DI MANTENIMENTO E LA
CAMERA STELLATA; L’IMPOSTORE PERKIN WARTEK SUL TRONO; ENRICO VIII E LO SCISMA
(Avvertenza filologica sullo scisma); ENRICO VIII E IL SUO PRIMO MATRIMONIO CON
CATERINA D’ARAGONA; LA STRAVAGANTE
AMBIZIONE DI THOMAS WOLSEY E SUA TRAMA SUL MATRIMONIO DEL RE; DIVORZIO DI ENRICO VIII E CADUTA IN DISGRAZIA DI
WOLSEY; WOLSEY PROMOTORE DEGLI STUDI UMANISTICI; SCOMPIGLIO DI
ENRICO VIII CREATO DA ANNA BOLENA; EMERGE THOMAS CROMWELL FINITO SUL ROGO - LA CONDANNA
PER ANNA BOLENA E’ MUTATA IN DECAPITAZIONE; NUOVO MATRIMONIO DI ENRICO CON JEAN SEYMUR RIFORMA DEL CULTO ED ESECUZIONE
DEI PARENTI E AMICI DEL CARDINAL POLO; ANNA DI CLEVES
E’ RIPUDIATA E CATERINA HOWARD FINISCE SUL PATIBOLO; L’ULTIMO MATRIMONIO DI
ENRICO CON CATERINA PARR E MORTE DEL RE; I PRIMI SUCCESSORI DI
ENRICO VIII: EDOARDO VI E JEAN GREY; MARIA LA SANGUINARIA
(BLOODY MARY); IL PASSAGGIO AL CATTOLICESIMO DURANTE IL REGNO DI MARIA RINFORZA IL PROTESTANTESIMO.
LA PROCLAMAZIONE DI
ENRICO VII
E LA SANGUINOSA
COMMEDIA
DELLA RIVOLTA
IRLANDESE DI
RICHARD SYMMONS
|
D |
alla
conquista (normanna) in poi, scrive David Hume (Histoire d’Engleterre, Paris
1873), non esiste nella storia d’Inghilterra un’epoca più incerta, meno
autentica e più contraddittoria di quella delle guerre fra le due rose (York e Lancaster).
Su molte
circostanze materiali gli storicìci differiscono e
alcuni avvenimenti della massima conseguenza su cui quasi tutti convengono,
sono incredibili e smentiti dagli archivi. E’ osservabile che un tal buio cade precisameente alla vigilia del Rinascimento delle lettere e
mentre in Europa già si conosceva la stampa. Attraverso la cupa nube che si
stende su questo lasso di tempo, trapela allo sguardo un’orrida scena di sangue,
di costumi selvaggi, di esecuzioni arbitrarie, di tradimenti disonorevoli da
ambo i lati.
Il patibolo
e i campi rosseggiavano del sangue più nobile dell’Inghilterra, sparso a
torrenti nella lite delle due famiglie contendenti, la cui animosità divenne
implacabile. Il popolo, diviso
nell’affezione, assunse simboli differenti del suo parteggiare. La
fazione dei Lancaster scelse per contrassegno di distinzione la rosa rossa; la York trasse la
denominazione dalla rosa bianca e queste guerre civili si resero
note in Europa sotto il nome della contesa
delle due rose.
La vittoria
riportata da Enrico VII a Bosworth (22 agosto 1485) e il matrimonio (1486) con Elisabetta
figlia di Edoardo IV, pretendente al trono come erede degli York, posero fine a
queste guerre intestine che da un secolo avevano insanguinato l’Inghilterra.
Enrico VII (1485-1509) era figlio
di Edmond Tudor conte di Richmond e di Margherita di Beaufort, figlia e unica
erede del duca John di Somerset, nipote di John de Gand, duca di Lancaster; ma colui da cui questa branca
traeva la sua origine oltre che adulterino, era bastardo.
Poiché il
duca di Lancaster aveva ottenuto la legittimazione dei suoi figli con una
patente di Riccardo II, confermata dal Parlamento, questa patente specificava
tutti i privilegi che erano accordati, da cui era escluso espressamente il
diritto di successione al trono (cit. D. Hume). Enrico sebbene avesse da prospettare
diversi titoli, come erede al trono, non poteva avanzarne nessuno, in quanto i
suoi titoli erano tutti contestabili e l’acclamazione era stata la strada più
legittima per giungere al trono, consacrato dal matrimonio con Elisabetta di York.
Enrico fu
infatti prima acclamato dai soldati, come vincitore della battaglia in cui
l’usurpatore Riccardo III era stato ucciso; sir William Stanley, che aveva
trovato tra le sue spoglie una corona di serto cinta da Riccardo in battaglia,
la mise sulla testa di Enrico che la ricevette senza esitare.
Enrico,
dopo aver fatto portare Elisabetta, che doveva sposare, a Londra, con un corpo
superbo composto dall’alta nobiltà e da gentiluomini del regno, si recò a
Londra dove lo ricevettero il lord sindaco e le corporazioni, con una folla di
borghesi e contadini che lo acclamava al suo passaggio; giunse quindi nella chiesa di san Paolo dove
fu consacrato lo stendardo della battaglia e furono resi solenni ringraziamenti
per la vittoria riportata, dopodiché si recò al palazzo del vescovo dove gli
era stato preparato l’alloggito che lo ospitava.
Seguirono
la assegnazione delle cariche, il matrimonio e la incoronazione; da Roma giunse
la bolla del papa Innocenzo VIII, che confermava la nomina del nuovo re e
pronunciava l’anatema contro chiunque ne turbasse la pace sua e dei suoi eredi.
Enrico VII pensò
quindi a mettere ordine nel regno recandosi nel nord, dove alcuni partigiani
della rosa bianca avevano preso le
armi e li disperse infliggendo loro punizioni severe. Le sue due passioni
dominanti erano la cupidigia e l’odio nei confronti della rosa bianca; ma il partito vinto cercò di vendicarsi.
Il suo prinipale agente era un prete di nome Richard Symmons che aveva la raffinatezza del mercante di Temple-Bar, alla quale univa l’audacia del contadino
gallese.
Symmons per dare la possibilità a Enrico
di acquistare ulteriori meriti, aveva ideato una rivolta in Irlanda e per
realizzarla, aveva prescelto un certo Lambert Simmel,
che sebbene fosse figlio di un macellaio di Oxford, aveva la prestanza fisica
che lo rendeva degno di un trono; costui doveva rappresentare Riccardo, secondo
figlio di Edoardo IV, che avendo avuto la possibilità di sottrarsi alle
crudeltà dello zio Riccardo III, si presentava a reclamare il titolo di cui era
stato spogliato e Simmel aveva organizzato questa sua
pericolosa commedia in Irlanda.
L’Irlanda,
di cui era stato governatore il duca di Clarence sembrava disposta ad
accogliere con favore il figlio del suo vecchio governatore di cui aveva un
buon ricordo e fu lì che si recò Lambert Simmel. Il
governatore dell’isola o, come lo chiamavano, il lord deputato, conte di Kildare, suo
fratello, cancelliere Thomas Fitz-Gerald e la maggior
parte degli ufficiali, erano ardenti yorkisti che
Enrico VII aveva lasciato in pace. Appena i due impostori giunsero a Dublino, Kildare presentava Simmel alla
nobiltà, ma la maggior parte della popolazione e il clero rimanevano dalla
parte di Enrico VII.
I rivoltosi
persistevano nella rivolta e a Dublino giunsero duemila mercenari tedeschi,
mentre Simmel fu portato sulle spalle, secondo l’uso
irlandese, dalla chiesa al castello e fu posto su un trono di velluto,
rivestito dalle insegne reali e in testa gli fu messa una corona presa dalla
Vergine della cattedrale e salutato come Edoardo VI.
Il 4 Giugno
1487 il monarca improvvisato sbarcava sulle coste del Lancashire
alla testa di ottomila uomini comandati dal conte di Lincoln e il 16 fu sconfitto
e ucciso nei pressi di Stoke tra Nottingham e Newark
con la metà dei suoi, in quanto la lotta era stata accanita e tedeschi e
irlandesi avevano combattuto con rivalità e coraggio.
Il prete Symmons, tradotto davanti al sinodo, confessò la sua colpa
e fu condannato alla prigione perpetua; il falso Edoardo VI,
re d’Inghilterra e di Francia, più degno di pietà e di collera, riprese il nome
del padre macellaio e finì come marmittone nelle cucine di Enrico VII e in
seguito, per la sua buona condotta, ottenne l’incarico di falconiere (J.A.Fleury Histore d’Angleterre, Ecosse et Irlande, Paris 1879).
IL DIRITTO DI
MANTENIMENTO
E LA CAMERA
STELLATA
|
E |
nrico VII approfittava
della sua vittoria di Stoke, non per versare altro
sangue, ma per costringere, a proprio vantaggio, con sostanziose ammende, le
più ricche famiglie yorkiste, portando così un colpo
terribile ai privilegi dell’aristocrazia con l’abolizione del diritto
di mantenimento.
Il mantenimento
era una associazione di individui retta da un capo. che indossavano una livrea,
che giuravano di sostenere, anche con le armi, questioni personali; con il mantenimento, il giurì era intimidito e
l’autorità impotente.
Un
tribunale speciale fu incaricato di punire tutti i prevenuti di coalizioni illegali o di
mantenimento, di sommossa e di intrattenimento di vagabondi, tribunale che
prese il nome dalla sala dove avvenivano le sedute, la cui volta rappresentava
il cielo stellato, detta “star chamber” camera stellaa.
Questa
corte criminale, destinata inizialmente a reprimere gli abusi della feudalità, al
tempo di Enrico VII era fondata sul diritto
comune (common law) e sull’antica pratica e all’inizio
del suo regno il Parlamento aveva confermato la sua autorità; Enrico VIII ne
aveva ampliato il potere e finì per diventare essa stessa un abuso
intollerabile del dispotismo monarchico ed Enrico VIII ne fece uno strumento di
comoda tirannia che aveva fatto scorrere lacrime e sangue; essa fu abolita da
Carlo I.
La star-chamber si componeva di un cancelliere, un
tesoriere, un guardasigilli privato, del presidente della corte del banco del
re, del presidente della corte delle udienze comuni, alle quali si aggiungeva
un vescovo e un lord temporaneo del consiglio del re; vale a dire che su sette giudici,
cinque erano dei servitori del re, revocabili a sua volontà e investiti del
diritto di chiedere due altri membri su cui si potesse interamente contare.
Enrico VII
non era stato crudele, era stato avaro; egli nelle guerre non aveva cercato la
gloria ma il mezzo di arricchirsi; chiedeva danaro al suo popolo per combattere
il nemico e lo chiedeva al nemico per
non fargli guerra, in modo da prenderne da ambedue le parti.
Fu così che
quando Enrico VII aveva occupato Boulogne con una
fanteria di venticinquemila uomini e milleseicento cavalieri e quando Carlo VIII aveva sposato Anna e si era impadronito
della Bretagna (v. Art. Carlo V ecc.
Parte II), aveva firmato il trattato di Etalpes (3 Nov. 1492); questo trattato prevedeva che Carlo VIII,
come re di Francia riconosceva che la sua sposa fosse debitrice verso la corona
inglese della somma di seicentomila scudi d’oro; egli si dichiarava debitore per gli arretrati
della pensione che suo padre, Luigi XI, si era impegnato a versare
all’Inghilterra, di centoventicinquemila scudi d’oro; in tutto settecento-quarantacinquemila
scudi, che si impegnava a pagare in quindici anni a Calais, in ragione di
cinquantamila scudi per anno.
L’IMPOSTORE
PERKIN WARTEK
SUL TRONO
|
M |
entre
Enrico VII stava affrontando questi problemi che soddifacevano
la sua avidità, un vascello proveniente da Lisbona, gettava l’ancora nel porto
di Cork in Irlanda, dal quale scendeva
un uomo dalla fisionomia rimarchevole; durante il viaggio si era mostrato
pensieroso e taciturno e nessuno lo conosceva; il suo nome era Perkin Warbeck.
Suo padre, Orbeck o Warbeck, ebreo
convertito, dopo aver lasciato Tournai sua patria, si era stabilito a Londra
dove aveva reso qualche servizio al re Edoardo IV, di cui aveva guadagnato
l’affetto; il re, per riconoscenza, aveva tenuto a battesimo il figlio che
ricevette il nome di Peter, in fiammingo Peterkin o Perkin. Quando più tardi si era messa in evidenza la
rimarchevole somiglianza del figlioccio col padrino, qualcuno aveva fatto
correre la voce che re Edoardo, noto per la sua galanteria, fosse qualcosa di più del padre spirituale
che volesse fare apparire.
A partire
dall’età di sedici anni, Perkins aveva errato in
diverse parti dell’Europa occidentale e aveva vent’anni quando giunse in
Irlanda, nella stessa isola in cui cinque anni più tardi, Lambert Simmel si era fatto passare per il giovane conte di Warwick (*) .
Egli si
faceva passare per Richard, duca di York, secondo figlio di Edoardo IV. Già
qualche signore irlandese aveva militato sotto il suo stendardo, quando Carlo
VIII che non aveva ancora firmato il trattato di Etaples,
aveva avuto l’idea di trarre profitto da questa singolare apparizione.
L’avventuriero
era stato accolto come un principe alla corte di Francia, ospitato al palazzo
reale, circondato dalla guardia d’onore. Più di cento distinti inglesi, si
erano recati a Parigi per riconoscere il figlio di Eoardo
IV e non avevano fatto alcuna difficoltà a prestar giuramento. Ma pretso Carlo VIII firmava la pace con Enrico VII e il
preteso duca di York, sacrificato, andava a chiedere asilo alla duchessa dotaria di Borgogna, sorella di Edoardo IV, che lo trattava
pubblicamente come suo nipote e gli dava il soprannome di Rosa bianca.
Enrico VII
mostrava disprezzo per un tale competitore e ordinava una inchiesta per
dimostrare l’assassinio del figlio di Edoardo; infine inviava degli emissari
nelle Fiandre e pubblicava di aver trovato nei loro rapporti la prova
irrefutabile che il preteso duca di York, non era che un ebreo di Tournai. Nel
frattempo, la duchessa di Borgogna, forniva a Perkin i
mezzzi per giugere in
Inghilterra.
Questo
primo tentativo sulle coste del Kent (1495) non era
stato onorevole e il pretendente si recava per la seconda volta in Irlanda e
non trovando gli abitanti ben disposti, si recava in Scozia dove Giacomo IV lo
accolse a braccia aperte. Non contento di riconoscerlo solennemente egli lo univa
in matrimonio a Caterina Gordon, alleata alla famiglia reale e una delle più
belle dame di corte; ma fece ancora di
più; egli, in due riprese (1496 e 1497)
invase il nord dell’Inghilterra.
Enrico VII
vedendo che il pericolo si faceva serio, intavolò delle trattative in seguito alle
quali fece condurre in Irlanda il duca e la sua sposa. Nel 1498 Perkin approfittò di una sollevazione degli abitanti della
Cornovaglia per sbarcare a White-Sand. Di là marciava
su Exeter e si illuse vanamente di impadronirsene, ma vedeva con terrore la sua armata disperdersi nella
piana di Tauton, quarant’otto chilometri da Exeter,
dove trovò rifugio presso l’abbazia Beaulieu
(Hampshire), che aveva ospitato Margherita d’Angiò prima della battaglia di Tewksbury.
Circondato
dalle truppe reali, finì per arrendersi e fu condotto a Londra e, attraversate
le strade di Londra, fu condotto alla Torre. In capo a un anno egli predispose
un piano di evasione con lo sfortunato conte di Warwick
(1499), piano che ambedue pagarono perdendo la testa,
La bella
scozzese di cui l’impostore aveva ricevuto la mano, fu assegnata come dama di
compagnia alla persona della regina facendone uno degli ornamenti della corte.
Il re Enrico VII, dopo aver procacciato
all’isola la quiete esterna a costo della dignità nazionale, l’interno col dispotismo,
con l’estorsione e col deprimere l’aristocrazia decimata dalla guerra delle due
rose, lasciava il regno (1509) al figlio con un milione e ottocentomila sterline e nessuna speranza di
affari (C. Cantù, Il sec. XV).
*) Edoardo Platntageneto conte di Warwick
figlio del duca di Clarence, era stato tenuto in una sorta di prigionia a Sherif Huatton dallo zio Riccardo
Plantageneto, alla cui corona avevano meno
diritto del nipote.
ENRICO VIII
E LO SCISMA
(Avvertenza filologica sullo scisma)
|
A |
vvertiamo il
lettore, che nella parte riguardante lo scisma di Enrico VIII, ci siamo serviti
del testo di “Storia ecclesiastica della
rivoluzione d’Inghilterra”, del padre Girolamo Pollini, fiorentino, domenicano dell’Ordine dei
Predicatori di Santa Maria Novella, del 1591, dedicato a Guglielmo Alano di
Lancaster (1531-1594): Pollini scriveva contro i protestanti e durante il regno
di Elisabetta aveva dovuto allontanarsi dall’Inghilterra e recarsi a Roma, dove
Sisto V lo aveva costretto ad accettare il cardinalato, che lui rifiuava; era stato inoltre incaricato di correggere la
Bibbia, pubblicata dallo stesso papa,
indicata da Sandero tra le sue opere, nel libro degli scrittori fiamminghi.
Padre Pollini
aveva tradotto dallo spagnolo la “Storia
dello Scisma d’Inghilterra”, in 3 voll. di
Sanderus (Sandero), che all’epoca aveva riscosso grande successo, aggiungendo,
per il suo libro, opere di altri
scrittori italiani, francesi e spagnoli (come egli dice, spesso senza citarli);
un’altra sua traduzione “Histoire du scisme en Engleterre” era
stata fatta in lingua francese da Maucroix (che
abbiamo anche noi consultato).
Padre Pollini,
di fede fondamentalmente cattolica, rimproverava ad Enrico, di aver ripudiato
Caterina, con il pretesto che fosse stata moglie di suo fratello, ma, in verità,
sosteneva lo storico, per sposare Anna
Bolena, dalla quale era stato preso da violenta
passione: ma su questa sua tesi o ipotesi non vi sono salde prove, che per il
caso non potevano essere che scientifiche, come l’esame del DNA, al quale non
si era ancora arrivati!
Anna (aveva scritto Sandero, ripreso da p. Pollini) era figlia di una delle sue amanti e sorella
di un’altra (Maria), di cui molti
hanno creduto, con stringenti
congetture, che fosse la propria figlia. Fu dunque per sposare Anna, che Enrico
aveva ripudiato Caterina e si era separato dalla Chiesa Romana. Ma non aveva
lasciato il nostro partito, sostiene Pollini, per abbracciare quello di Calvino o Zwigli
o per qualche altra antica religione eretica. Egli aveva formato una nuova
religione di cui si era fatto capo sulla terra. Anna, per se stessa, non sapeva
governarsi con saggezza né prima. né dopo il matrimonio; suo fratello fu
accusato di aver intrattenuto con lei disonorevoli rapporti e per di più lei professava
la religione luterana. Infine fu condannata dai giudici per adulterio e incesto
ed ebbe la testa tagliata per ordine di suo narito.
Così la
religione protestante, aveva scritto Sandero (ripreso da p. Pollini), è fondata
sulla ipocrisia (*) di Enrico che per un rimorso di coscienza, aveva ripudiato
Caterina mentre essa è fondata su un duplice incesto, in quanto non si può
negare che Enrico abbia commesso incesto sposando la figlia o la figlia di una
donna che intratteneva rapporti con lui; e che Anna potesse passare per
incestuosa per le libertà che si pemetteva con suo
fratello. E’ quindi - concludeva
Sandero - su questi presupposti, che lo
scisma si è stabilito in Inghilterra sotto il regno di Enrico, Edoardo VI ed Elisabetta.
P. Pollini,
al quale stava a cuore la regina Caterina, riprendendo Sandero, scriveva che
Enrico, ripudiandola, si separava dalla Chiesa Romana per correre dietro ad
Anna Bolena, sulla quale, sulle tracce di Sandero, avanzava l’ipotesi che fosse anche sua figlia,
scagliandosi contro Edoardo VI ed Elisabetta, in
maniera più violenta di Sandero e forzando la realtà, ne diceva peste e corna:
“per aver reso l’Inghilterra una spelonca
di ladri, sentina di tutti i vizi, nido di infiniti malfattori e malvagi.
franchigia dei più scellerati nemici di Cristo. Spero che questa storia - egli
aggiungeva - spiegandovi avanti agli
occhi una sanguinolenta scena bagnata del sangue di infiniti martiri, piena di
oltraggi fatti alla santa madre Chiesa, unica sposa di Cristo, colma soverchie
ingiurie fatte ai romani pontefici, di una disdicevole sostituzione della
religione cattolica, nella sporca ed empia setta di Calvino e Zwigli che, non solamente con le lacrime ma con le orazioni
e con la forza e con le armi sarà domata quest'idra, cacciati questi mostri
infernali, spiantar queste rapaci arpìe del mondo e
purgar finalmente la meschina Chiesa d'Inghilterra dal mortifero veleno
dell'eresia”.
Non ci
dispiace citarli, anche per dimostrare quanto fosse divenuta estrema e sanguinosa
la lotta della Chiesa con tutto il sangue che era stato fatto scorrere anche
altrove, p. es. in Francia e Germania (**), contro l’affermarsi delle nuove
idee introdotte da Lutero (ricordiamo che le nuove idee, volere o no, se non si
affermano per evoluzione, si affermano per rivoluzione!).
E li
citiamo anche perchè questi autori introducono
argomenti non trattati da altri, in ogni caso da verificare; come p. es. le
date; infatti. relativamente alla circostanza che Thomas Boleyn
fosse stato mandato come ambasciatore in
Francia da Enrico VIII, per poter avere la libertà di frequentare la moglie,
madre di Anna Bolena; Thomas aveva intenzione di disconoscerla, facendo ricorso
a un processo (***) al quale era stato poi convinto a rinunciare; abbiamo
trovato però che non vi è corrispondenza nelle date, per cui su queste
circostanze, possono sorgere dei dubbi.
In ogni
caso, a proposito del conclamato incesto
da parte della Chiesa, occorre tener presente che ai tempi della Bibbia i
rapporti tra padre e figlie erano consentiti, come la famosa citazione delle
figlie del patriarca Lot; poi man mano che si
procedeva nella regolamentazione del cattolicesimo, erano stati considerai
peccaminosi.
*) Non vi è dubbio comunque, che il
mondo civile si regga sulla ipocrisia,
quantomeno corrente-equilibrata, come ci spiega Torquato Accetto nel
suo testo, “Della dissimulazione onesta”.
**) Lo
vediamo realizzarsi ancora oggi (2022-23-24) da parte del regime teocratico
dell’Iran, dove si torturano, stuprano,
si impiccano e hanno inventato l’avvelenamento
delle ragazze a scuola, per evitare che vi si rechino, nel nome di un Dio, che consente
tante brutalità; tutte giovanissime vite umane che chiedono semplicemente la
libertà dalla oppressione religiosa; nell’indifferenza dell’ONU e del suo
Segretario, che non prendono provvedimenti!
A proposito
delle persecuzioni religiose messe in atto da Maria la Sanguinaria, come riferiamo nell’apposito paragrafo, David Hume
aveva scritto “L'uomo non si mostra
mai tanto detestabile e
irragionevole quanto nelle persecuzioni
religiose, che lo pongono, in malignità, a livello degli spiriti infernali e al
disotto delle bestie in frenesia”.
***) La madre di Anna era Elizabeth
Howard (1480-1538), figlia di Thomas Howard duca di Norfolk, discendente di
Edoardo III, ed Elizabeth Tilney. Thomas, riferisce
Sandero e Pollini, la citò per ripudiarla come adultera, davanti
all'arcivescovo di Canterbury, ma poi il proceso non
ebbe luogo.
ENRICO VIII E IL SUO
PRIMO MATRIMONIO CON
CATERINA D’ARAGONA
|
E |
nrico VII alla fine dei movimenti che avevano
agitato l’Inghilterra e quando essi si erano calmati e il trono non sembrò più
vacillante, aveva pensato a trattare il matrimonio del suo primogenito Arthur
di quindici (o sedici) anni, che non godeva di buona salute; era infatti nato
di otto mesi e i medici avevano detto che non sarebbe vissuto a lungo; ma a
quel tempo i matrimoni erano affari di Stato e non si pensava all’età o alle
condizioni di salute dei bambini, che erano merce dis
cambio.
Il matrimonio di Arthur fu deciso per la figlia
diciottenne di Ferdinando e Isabella. Caterina d’Aragona, che portava il
prestigio della casa reale spagnola e una ricchissima dote di duecntomila scudi.
Il matrimonio ebbe luogo il 14 Novembre 1501 e tra i due sposi non vi era stato alcun rapporto
fisico con la sposa ed Arthur moriva dopo cinque mesi dal matrimonio, lasciando
vergine Caterina.
Enrico VII, notoriamente avaro, sia per non
restituire la dote, della quale ne aveva riscosso la metà, sia per mantenere
legati i due regni e calmare ogni inquietudine con i reali di Spagna, si accordava
con l’espediente del matrimonio tra il dodicenne principe di Galles, Enrico
(futuro Enrico VIII) e la vedova del fratello.
Ma occorreva la dispensa del papa, al quale fu
mandata la richiesta ed Enrico VII che doveva ricevere l’altra metà della dote,
volle che essa fosse versata prima del secondo matrimonio. Ma trovò
l’opposizione di Ferdinando, anch’egli avaro, che sosteneva che essa dovesse
rimanere dote nominale; comunque i due monarchi rimandarono la questione al
consenso del papa Giulio II.
Il problema non era semplice in quanto questo
genere di matrimonio era vietato dalla Bibbia e la prima richiesta decisiva
della Santa Sede fu quella di sapere se il matrimonio tra Arturo e Caterina
fosse stato consumato; avuta risposta che il matrimonio non era stato
consumato, la dispensa giunse il 6 Dicembre 1503 e i due giovanetti furono
solennemente fidanzati.
Ma, il re Enrico VII, prima di morire,
probabilmente preso dal rimorso, aveva fatto firmare dal figlio Enrico un atto
col quale il giovanetto (che all’epoca aveva dodici anni) si impegnava a non
sposare Caterina (Reynal, Le Divorce de Henri VIII et
Catherine, Amsterdam 1763)), ma, quando Enrico aveva raggiunto i quattordici
anni, in presenza di testimoni, dichiarava che non avrebbe sposato nessun'altra,
se non Caterina.
Enrico VIII
(1491-1547) alla morte
del padre (1509), aveva diciotto anni;
era aitante, attivo, studioso e particolarmente
versato negli studi di religione (scolastica e teologia) più che a un principe
non convenisse. Scriverà infatti un libro (in cui vi era la mano di Wolsey e
Moro) contro Lutero col titolo “Assertio septem sacramentorum adversus Martin Luther”:
Difesa dei sette sacramenti contro Lutero, che gli farà ottenere dal papa il
titolo di “defensor fidei”.
Lutero
rispose subito con un libro violento, col quale negava che fosse stato scritto
da lui; poi gli scrisse una lettera scusandosi per l’acredine che aveva usato, che era rivolta piuttosto nei
confronti di coloro che avevano rimaneggiato lo scritto e speculato sul suo
nome.
Enrico cominciò
il regno con feste, tornei e caroselli, attingendo al danaro lasciato dal padre,
non solo, ma spingendo con l’esempio, i signori, a metter fuori le nascoste
ricchezze; componeva musica e puniva i concussori,
modi certi per acquistare popolarità ed era strabocchevolmente cupido dei
piaceri.
Il primo atto del nuovo re fu di far esaminare
e confermare il legame che egli aveva fatto con la vedova del fratello, dal
Consiglio reale. Tutti i ministri convennero che gli interessi politici lo
richiedevano, ma
solo
l'arcivesovo di Canterbury e qualche altro ministro avevano suggerito
che la religione lo vietasse, ma questa opinione fu abbandonata e il matrimonio fu celebrato sfarzosamente lo
stesso anno (1509).
La nuova regina non tardò ad apparire incinta,
ma i bambini che partoriva non vivevano che poche settimane (*); Maria fu
l’unica a sopravvivere e, come erede al trono, fu dichiarata principessa del
Galles.
Caterina, piccola di statura e non bella, con
un viso dalle linee dure, ma era una donna virtuosa, di costumi semplici, dalla
vita ritirata; l’amore per l’ordine formava il suo carattere; le cure
domestiche, le preghiere e il lavoro erano le sue principali occupazioni. Non
aveva talenti e ancor meno pretese,
nessuna inclinazione e interesse per gli affari del regno e tantomeno aveva
espressioni di femminilità; mancava infatti della grazia femminile e del
desiderio di piacere; per di più era presa da tristezza e malinconia che
aumentavano con l’età e probabilmente erano queste a procurarle le false
maternità.
Con queste premesse i due sposi reali vivevano
in armonia, nell’indifferenza di Enrico che si distraeva con le sue scappatelle con le giovanette, che pescava
tra le danigelle della regina; una delle ultime scappatelle era corsa con
Maria Bolena che Enrico aveva portato tornando dalla Francia (1520)
togliendola a Francesco I, che le aveva lasciato un ricordo venereo, passato, a
sua volta, a Enrico.
Un bel
giorno (1525), a corte, tra le damigelle d'onore della regina era apparsa
Anna Bolena, sorella di Maria, proveniente dalla corte francese; questa giovanetta magra, dal corpo sottile
con gli occhi e capelli neri, con modi francesi, e vestita alla francese, portava
lo scompiglio nel tranquillo rapporto tra i due reali coniugi.
*) La moria
dei bambini e delle madri era determinata principalmente dalla diffusione di
batteri per mancanza di igiene e nel caso di
Enrico probabilmente anche a causa della sua malattia
genetica v. par. Anna Bolena
LA STRAVAGANTE
AMBIZIONE DI
THOMAS WOLSEY
E SUA TRAMA SUL
MATRIMONIO DEL RE
|
T |
homas
Wolsey era figlio di beccaio di Ipswich (come riferisce padre Pollini che
riprende Sotero), il quale volle dare una educazione
al figlio e lo aveva avviato alla vita ecclesiastica; ammesso alla università
di Oxford per le sue doti intellettive, ottenne un brillante successo e fu incaricato di
seguire l’educazione di giovani appartenenti a famiglie distinte del regno.
era stato
per poco tempo al servizio di Enrico VII e alla sua morte era entrato nelle buone grazie di Enrico VIII e la
sua carriera era stata rapida e brillante; iniziata come cappellano del re e subito
dopo, per mezzo del vescovo di Winchester, divenuto elemosiniere.
Quando
Enrico si era impadronito di Tournai, nelle Fiandre (1515), Wolsey era stato
investito di quel vescovado e delle sue entrate; non molto dopo, ebbe la carica
di vescovo di Lincoln e Durham e poi di Winchester e arcivescovo di York con le
sostanziose entrate; dopo due anni ebbe la carica di Cancelliere del regno e il
papa lo nominava legato a latere,
vale a dire suo rappresentante nel regno d’Inghilterra.
Amante
della munificenza e dello sfarzo, indossava abiti di seta e oro e ne guarniva
anche le selle e le gualdrappe dei cavalli; usava far portare il cappello
cardinalizio posto su un cuscino, da un personaggio d’alto grado e quando
entrava nella cappella del re, lo faceva deporre sull’altare. Si faceva
precedere anche da un prete, alto di statura e avvenente, che portava una
colonna d’argento con una croce e non soddisfatto di questo sfoggio, al quale
si sentiva autorizzato come cardinale, aveva aggiunto un altro prete, di pari
bellezza e statura, che portava la croce di York e il popolo se ne prendeva
gioco dicendo che un crocifisso non bastava ad espiare i suoi peccati e le sue
colpe. John Stow che aveva scritto (1598) un interessantissimo
libro di curiosità su Londra di quel periodo “A survey London” (Veduta di Londra),
nel quale diceva che Wolsey aveva quattrocento serventi.
Wolsey era
riuscito ad ottenere dal re di Francia e dall’imperatore Carlo V ricche abbazie
ed era divenuto il padrone assoluto del regno; era stato detto: “che il suo gusto era preso non tanto dal
gusto per le cose, ma dal disgusto che lo prendeva la mancanza di ciò che
desiderava”.
Carlo V
avendo intuito la sua stravagante ambizione, gli scriveva lettere personali
firmandole “vostro figliuolo e parente
Carlo”, e, nell’intento di ottenere una confederazione con Enrico VIII ,
per muovere guerra a Francesco I, gli aveva promesso che alla morte di Leone X
sarebbe diventato papa.
Ma, alla
morte di Leone X Carlo V aveva
appoggiato la nomina di Adriano VI (1522-1523) suo maestro
e Wolsey, ritenendo di dover dissimulare, sopportò con pazienza e attese la
morte di Adriano, per la quale non dovette attendere molto.
Quando però
alla morte di Adriano fu eletto Clemente VII (1523-1534), Wolsey accorgendosi
di non essere tenuto in molta stima dall’imperatore
e le poche lettere scritte da Carlo, non erano più scritte di proprio pugno, ma
par mano dei segretari, Wolsey passò interamente dalla parte di Francesco I.
Sapendo che
Enrico aveva in animo di separarsi da Caterina, (aveva sentito da un astrologo
che “una femmina stava per essere causa
della sua rovina” e aveva ritenuto che questa non potesse essere che
Caterina), fece chiamare John Longland, vescovo di
Lincoln, uomo semplice
e scrupoloso, più di pietà che di scienza, che faceva tutto ciò che lui gli
suggeriva; dopo avergli parlato del matrimonio del re, che era contrario alla
legge di Dio, lo nominò confessore di Enrico (1526) e convinse Longland che gli stava a cuore la salvezza dell’anima del
re, con l’intento che gli riferisse tutti i suoi segreti, concludendo che il
suo matrimonio con Caterina non gli pareva ben fatto e pericoloso per la
coscienza di Enrico.
Longland convinto che ciò che gli aveva
detto Wolsey non sarebbe dispiaciuto al re, non ritenne di replicare o
contraddirlo, ma ritenne opportuno che fosse Il cardinale a riferire al re la
sua opinione sul suo matrimonio con Caterina; ciò che Wolsey fece durante una
conversazione con il re, accennando al riferimento della Bibbia, del divieto
posto al fratello, di sposare la vedova del fratello.
Dopo che Wolsey aveva ventilato a Enrico questo divieto posto
dalla Bibbia, Enrico aveva cominciato a
pensare a elaborare il pensiero del ripudio di Caterina, non solo dedicandosi
allo studio dell’argomento, ma pensando di conferire l’incario
a dei teologi, per approfondire il caso ed esaminare anche la dispensa a suo
tempo avuta dal papa Giulio II e chiesta quando doveva sposare Caterina.
Il vescovo Longland quindi
riferiva a Enrico, che come confessore del re, in coscienza, si sentiva in
obbligo di dirgli che tutto il mondo era scandalizzato del suo matrimonio con
Caterina e che egli si sentiva obbligato a suggerirgli di volerlo far esaminare
da teologi, anche fuori del regno. Questo discorso aveva fatto una certa
impressione sul re, sul quale interveniva Wolsey, che gli suggeriva di rompere il matrimonio con Caterina.
Relativamente
alle sollecitazioni di Wolsey e del suo confessore, mentre Wolsey pensava al possibile
matrimonio con la sorella del re di Francia, Enrico pensava in cuor suo al
fidanzamento (non ancora al matrimonio!)
con Anna Bolena e scrisse al sommo pontefice Clemente VII, il quale, avendo dei
dubbi su una questione così importante, aveva
convocato i teologi che si trovavano a Roma.
Mentre
Enrico, dal suo canto, aveva mandato suoi confidenti, fra i quali Richard Crock, in Italia, per interpellare eruditi di Ferrara,
Bologna, Padova e Venezia dove primeggiava Francesco Giorgio (noto per la sua
opera “De Armonia Mundi”, Dell’armonia del mondo), offrendo a costoro un
ragguardevole premio.
I
pareri non furono uniformemente favorevoli ad Enrico in quanto, mentre (si era ritenuto), che alcuni
eruditi si erano mostrati favorevoli in quanto interessati al premio (ciò che non si poteva dire di
Giorgio che si era mostrato favorevole a Enrico, la cui onestà era nota), il giudizio del papa e della Santa sede era stato
negativo per il re.
Per di più era in ballo con i francesi non solo il matrimonio di Maria,
principessa del Galles, con il duca d’Orleans, o con lo stesso Francesco I, che
stava trattando Wolsey, interessato a stringere i rapporti con i francesi che
gli avrebbero dato ricchi riconoscimenti.
Egli però non immagnava che le segrete
intenzioni di Enrico, fossero quelle di divorziare da Caterina per sposare Anna
Bolena, mentre egli mirava al matrimonio di Enrico con la sorella di Francesco
I, duchessa d’Alençon (rimasta vedova del duca d’Alençon), che avrebbe rafforzato la sua personale posizione e
nello stesso tempo avrebbe salvaguardato la pace dei due regni. mentre Anna Bolena
poteva esser tenuta come concubina (cit. padre Pollini).
Questi
avvenimenti si stavano verificando quando le truppe di lanzichenecchi del duca
Carlo di Borbone saccheggiavano Roma (1527) e il duca era ucciso da una
schioppettata che Benvemuto Cellini
si vantava di avergli sparato e
quando Francesco I era liberato dalla
prigionia di Carlo V, sostituito dalla consegna dei suoi due figli (v. in Art.
Diana di Poitiers ecc.).
IL DIVORZIO
DI ENRICO VIII
E CADUTA IN DISGRAZIA
DI WOLSEY
|
I |
l papa Clemente
VII aveva mandato il cardinale Campeggio in Inghilterra con l’incarico che con
il cardinale Thomas Wolsey fosse deciso il divorzio; l’udienza fu fissata nel
convento di san Domenico (28 Maggio 1529),
alla quale il re non comparve, ma
interveniva solo Caterina che non ritenendo
regolare la procedura, si appellava al papa, perché: Il luogo non era idoneo per un giudizio; i
giudici erano sospetti in quanto erano obbligati e soggetti al re, in quanto
Wolsey era titolare di vescovati inglesi e Campeggio di un vescovato donatogli dal re; essi non
accogliendo l’appello al papa, facevano cosa grata al re.
Presentatosi
successivamente il re di persona, disse che egli era spinto a chiedere il
divorzio, non dall’odio verso la regina, ma da scrupolo di coscienza e che i
giudici erano uomini dottissimi, nominati dal sommo pontefice, supremo capo
della Chiesa, ai quali si potesse dare l’incarico di risolvere la lite, mentre dal
suo canto, la regina sollecitava l’accoglimento del suo appello al papa.
Alla udienza
erano convenuti esponenti del parlamento e popolo e la regina sedeva dalla
parte sinistra, mentre il re era sulla destra, sotto un baldacchino; la regina,
mettendoglisi davanti in ginocchio gli disse che
mentre lui era re nel suo reame, lei era una forestiera e lo pregava umilmente
e amorosamente, di far proseguire la lite in Roma, presso il papa, padre di
tutti i cristiani e giudice accettato dallo stesso re. Il re, levatosi in piedi disse che accettava
di buona licenza ciò che chiedeva la regina.
Il papa, accogliendo
la richiesta di Caterina richiamava il cardinale Campeggio e disponeva che la
causa fosse trattata a Roma assegndola a Paolo Capisaco,
decano del Sacro Palazzo Apostolico. Fissata l’udienza per la comparizione dei
procuratori delle parti, la regina era rappresentata da Tommaso Moro: la
sentenza emessa (1528), respingeva la richiesta di divorzio.
Enrico aveva
un trabocco d’ira, addossando tutta la colpa a Wolsey e ne approfittarono tutti
coloro che odiavano il cardinale per invidia, i quali scrissero un memoriale di
malvagità che presentarono al re.
Procuratore
del re era il suo segretario Stefano Gardner, il quale al ritorno da Roma
chiese a Wolsey, in presenza del re e del Consiglio reale, di indicare chi
fossero stati gli autori e inventori del divorzio. “Non potrò mai negare di essere stato io solo - rispose Wolsey - che se questa causa a quest’ora non fosse
cominciata, aggiunse, giudicherei che
quanto prima dovesse comimciare”.
Il re non
fece trasparire i suoi sentimenti, ma quando Wolsey si era presentato per la solita conversazione con
Enrico, non fu ammesso all’udienza e Wolsey si rese subito conto dei sentimenti
covati dal re; privato del vescovato di
Winchester, assegnato a Stefano Gardner,
non molto tempo dopo il re nominava Cancelliere, prima Thomas Howard, duca di
Norfolk, e poi Tommaso Moro (1529).
Moro,
vedendo che i provvedimenti del re e del parlamento inclinavano a una
separazione dalla Chiesa di Roma e a un cambiamento di religione, che si
opponevano ai suoi fermi principi, rinunziò al gran sigillo e scese dallo scanno (1532) con maggior
soddisfazione che non avesse provato nel salirvi (cit. D. Hume).
Di grande
intelletto e di spirito allegro, scherzoso e bizzarro, Moro, aveva disposizione per le facezie e per i motteggi;
il re cercava la sua compagnia e amava conversare con lui; Moro era legato alla religione fino al più stretto
integralismo; infatti, quando fu coinvolto nella questione del divorzio del re,
volle dar prova della sua fermezza di carattere accettando il martirio.
Moro si era
rifiutato di rionoscere, secondo la legge statutaria, che il re fosse costituito capo supremo della
Chiesa d’Inghilterra e aveva assunto la insolita posizione di non dare una
risposta, in base al brocardo romanistico secondo il
quale “qui tacet,
neque negat neque utique faterur”,
vale a dire che chi tace non nega, né in alcun modo parla, o, come egli soleva
dire “l’Atto del Parlamento è come una
spada a doppio taglio, perché se si risponde in un modo, si rischia la morte
dell’anima e se si risponde nell’altro, si rischia la morte del corpo”.
Era tanto convinto
della vita eterna dell’anima, che alla moglie che lo scongiurava di obbedire al
re e conservare la vita, rispose che non intendeva scambiare venti anni della
vita terrena con l’eternità!
Anche sul
patibolo Moro non aveva perso il suo senso dell’humor in quanto, mettendo la
testa sul ceppo, la sua lunga barba sarebbe stata in gran parte tagliata; pregò
il boia di accomodargliela in modo che non fosse tagliata; il boia, meravigliato,
gli disse: che vi importa della
barba quando avrete tagliata la testa; Moro
soggiunse; Non importa a me, ma bene a te, per essere censurato di
non saper fare bene il tuo dovere, essendo stato comandato di tagliarmi il capo
e non la barba!
Tornando a Wolsey,
dopo aver soggiornato ad Asher, aveva ottenuto di
passare a Richmond, avuto in compenso di Hampton-Court,
da cui i nobili avevano ottenuto di farlo sloggiare (questo palazzo era stato
definito da Gregorio Leti il più superbo, magnifico,
delizioso d’Europa); avendo poi dovuto lasciare il vescovato di York, Wolsey
aveva fissato la sua dimora a Cawood nello Yorkshire dove era stato molto apprezzato per la sua gentilezza
e ospitalità.
Dovendo
celebrare un pontificale, voleva indossare una mitra piena di gemme che gli era
stata sequestrata dal re e aveva mandato a richiederla, ma il re aveva dato
ordine al conte Enrico di Northumberland, di arrestarlo
per fellonia e condurlo a Londra per essere processato. Improvvisamente durante
il viaggio, Wolsey fu colto da diarrea e fu condotto alla badia di Leicester dove
disse ai monaci che vi si era recato per lasciarvi le sue ossa; messo a letto
non si rialzò più (cit. D. Hume); per questa sua morte improvvisa si era
sospettato che si fosse avvelenato, ma è probabile che la morte (1530) fosse
stata naturale, togliendo così al suo re, il gusto di fargli tagliare la testa!
L’immensa quantità dei beni da lui accumulati gli fu sequestrata con York Place e poi Withe Hall, che egli aveva
fatto ampliare ed arredare con magnificenza, Enrico ne fece residenza reale.
WOLSEY
PROMOTORE DEGLI STUDI
UMANISTICI
|
I |
l nome di
Thomas Wolsey e della sua genialità, è legato agli studi umanistici che si
erano affermati in Inghilterra nel XVmo sec., con
Enrico VII e proseguiti con Enrico VIII ed Elisabetta.
Il celebre
grammatico William Lilly che aveva studiato greco a
Roma, aveva aperto per primo un corso di greco (1512) presso la Scuola di San
Paolo, fondata da John Colet (1467-1519), considerato
uno degli uomini più colti della sua epoca. Wolsey, come promotore successore
di Fox, aveva fondato un scuola a Ipswich (sua città natale) e il Collegio del Corpus Christi
a Oxford, dove alle altre cattedre, ne aveva aggiunte due, una di retorica e
umanistica e l’altra per l’insegnamento del greco.
Aveva
inoltre aveva inviato una lettera a tutti gli insegnanti del regno, invitandoli
a insegnare ai giovani la elegante letteratura greca e latina. Erasmo aveva
elogiato il grande cardinale, dicendo che aveva introdotto nel suo paese le lingue
classiche, senza le quali nessuna istruzione sarebbe stata mai perfetta.
Malgrado il potente patronato di Fox e Wolsey, gli studi da essi introdotti
avevano avuto numerore resistenze e attacchi. Colet, in una lettera a Erasmo, gli riferiva di essere
stato censurato in una pubblica assemblea, di avere una casa di idolatria. Ma dopo qualche tempo, man mano che i
riformatori si andavano affermando, essi divennero i principali sostenitori del
greco e i nuovi studi avevano trovato caldi partigiani tra i cattolici.
E’ noto che
i riformatori avevano stabilito l’onnipotenza delle Sacre Scritture proprio nei confronti dei loro avversari: i
costumi, la tradizione i decreti dei papi e dei concili, la stessa traduzione
latina, per essi non avevano alcun valore, né costituivano punto di fede (come
era stato stabilito dai cattolici); il testo originale del Nuovo Testamento
greco, era il solo testo che essi ritenevano ammettere; per questo si doveva
studiare il greco. Le prime edizioni del Testamento greco del cardinale Ximenez erano del 1514, pubblicate nel 1522; nel 1516
apparve il Nuovo Testamento di Erasmo, che aveva suscitato violenti clamori in
quanto si diceva che il libro contenesse sue invenzioni e che egli aveva
intenzione di stabilire una nuova religione.
Erasmo aveva
cercato di calmare la tempesta facendo riferimento alla grammatica greca di Crisolora (pubblicata da Aldo Manuzio
v. Art. Ventata di umanesimo ecc.);
ma i clamori erano contro di lui e il suo Nuovo Testamento era stato messo
all’indice e i funzionari delle università avevano dichiarato che tutti coloro
che fossero stati trovati in possesso di quest’opera, sarebbero stati puniti
con un’ ammenda.
Le
università inglesi, come quelle d’Europa, erano divise i greche e troiane; queste
ultime avversavano i nuovi studi e reclutavano i loro membri per mezzo dei
monaci e partigiani della vecchia religione. I troiani perdevano terreno quando Enrico VIII che aveva
grandi pretese e spirito versato per gli studi, si era mostrato favorevole ai
nuovi studi. E sia per capriccio, sia per amore della novità, egli aveva
accolto queste innovazioni che ottennero considerevole successo.
Erasmo
riferiva che un predicatore dell’Università di Oxford, avendo arringato con
violenza, gli uditori, vietando loro di leggere le Scritture nella lingua
materna; questo predicatore era stato approvato da Enrico, che emetteva un’ordinanza
con la quale permetteva lo studio delle Scritture in greco ed in ebraico,
dichiarando che questo studio costituiva una branca indispensabile di tutta
l’istruzione accademica.
In altra
occasione, uno dei cappellani del re, avendo attaccato con violenza lo studio
del greco, Enrico, subdolamente gli aveva ordinato di sostenere pubblicamente
la sua tesi con Tommaso Moro ... che lo
riduceva al silenzio ... e il cappellano dichiarava di essersi riconciliato con
la lingua greca, in quanto aveva ritenuto che essa derivasse dall’ebraico; dopo
che cadendo in ginocchio davanti al re, gli chiedeva perdono e il re dandogli
il permesso di ritirarsi, gli ingiungeva di non più comparire innanzi a lui.
Sotto il
regno di Maria le lettere e le scienze furono oggetto di una specie di culto;
Elisabetta l’aveva seguita e aveva avuto tutto il tempo per farle accrescere;
lo studio del francese, che dopo la conquista normanna era la lingua più usata
dell’inglese, dalle scuole alte fu estesa alle medie; l’italiano e lo spagnolo
divennero di moda e la lingua inglese di quel periodo differiva di poco da
quella precedentemente parlata; questo periodo era stato designato come l’epoca
della cultura dai numerosi personaggi che erano emersi come Cranmer,
Ridley, de Tunstal, Gariner,
Pole e i molti ecclesiastici che si erano distinti, come Richard Pace, sir John
Cheke e sirThomas Smith; e
di ellenisti, oltre a Colet e Lilly
vi furono John Leland al quale l’Inghilterra deve la
conservazione di monumenti preziosi senza la quale sarebbero periti sui quali brillava la stella di Tommaso Moro,
con Desiderio Erasmo che era stato suo amico; nella medicina aveva primeggiato
Thomas Linacer, uno degli uomini più istruiti del suo
tempo; Roger Asham, che scriveva in inglese e latino,
era l’autore del “Toxophilus”
(La scuola di tiro), l’unico libro
scritto in Occidente sul tiro dell’arco, in pace e in guerra, in versi e in
inglese, pubblicato nel 1553, ammirevole per l’eleganza e la purezza di stile
Il
latinista Walter Haddon, Buchanan
che scriveva versi latini, l’arcivescovo Parker, il vescovo Andrews,
Thomas Wilson che aveva scritto un trattato sulla retorica. Molti di costoro
erano del tempo di Enrico VIII che aveva la predisposizione per le lettere e le
scienze in quanto nella sua infanzia era stato avviato alla carriera
ecclesiastica e i suoi tre figli anche
se di salute cagionevole, erano dotati di alte doti intellettive.
Erasmo
aveva commentato diverse lettere di Maria, scritte inn
Latino; Elisabetta (v. P.II), scriveva e parlava in
latino , francese, spagnolo (che non amava) italiano e in greco. Asham che le aveva insegnato questa lingua, aveva detto che
dopo essere salita al trono, leggeva spesso dei passi di autori greci. In
questo periodo erano emerse molte donne colte, come Jean Grey
di cui abbiamo già detto che leggeva Platoni in
greco, la contessa Maria di Arundel lady Jean Lumely e la duchessa Maria di Norfolk che avevano tradotto
opere dal greco inm latino e in inglese; le due figlie
Joane o Jane aveva sposato John Clement,
suo professore e Margaret che aveva sposato William Roper,
biografo del Cancelliere. considerta una delle donne
più colte della sua epoca, e infine le ttre figlie di
sir Anthony Cooke, Mildred
che aveva sposato lord Burglay e il suo nome era
stato cantato dalla musa di Buchanan; Anne, la
seconda divenne governante di Edoardo VI, e più tardi
sposò sir Nicolas Bacon; e Catherine la più giovane che aveva sposato Henry Killigrew, rinomata per la sua erudizione, che oltre al
greco e latino, conosceva l’ebraico.

Ritratto di ignoto
Firenze – Galleria
degli Uffizi
LO SCOMPIGLIO
DI
ENRICO VIII
CREATO DA
ANNA BOLENA
|
A |
nna Bolena, quindicenne, si era recata in
Francia (1515) al seguito della sorella di Enrico VIII, la principessa Maria (1496-1533), divenuta regina di
Francia per aver sposato Luigi XII, lei di sedici anni (ma, ad ogni buon conto,
aveva già dato il suo “cuore” al giovane
visconte di Lilla che l’accompagnava che diventerà duca di Suffolk), lui di cinquantatré, carico di acciacchi, il quale preso
dall’erotismo che gli suscitava la bella e giovanissima moglie, dopo tre mesi
di matrimonio, rendeva la sua animaa a Dio.
Per il
ricambio avvenuto a Corte, Anna rimaneva come damigella d'onore della nuova regina
Claudia, moglie di Francesco I, che era succeduto a Luigi XII, e dopo la morte
della regina Claudia, diveniva damigella
d'onore della duchessa d’Alençon, sorella di Francesco I; dopo questo apprendistato, rientrava
in Inghilterra (1525) accolta a Corte
come damigella della regina Caterina (che in quel periodo aveva quarantasei
anni, Anna ventisei ed Enrico trentotto).
Alla
Corte francese prima di Anna, vi era stata la sorella, Maria Bolena, che era
una bella ragazza con labbra voluttuose, colta nella sua freschezza da
Francesco I, portatore di sifilide che dispensava alle sue amanti (v. in Art.
Diana di Poitiers ecc.) e quando Enrico
si era recato al Campo del drappo d’oro (*), l’aveva presa con sé, riportandola
in Inghilterra.
Il
nonno delle due sorelle Maria e Anna,
era Goffredo Boulen, mercante, che era stato sindaco
di Londra (1457); il primo a distinguersi nella famiglia; era stato suo figlio Guglielmo a elevarsi di grado, sposando
una figlia di Thomas Butler conte di Ormond; il figlio di costoro, Thomas Boulen aveva sposato Elisabeth, figlia di Thomas
Howard duca di Norfolk, da cui aveva avuto un maschio, Giorgio, visconte di Rochefort e due femmine, che erano Maria, che in seguito sposava
William Carey, Gran Scudiero e Anna; le due sorelle, come abbiamo detto, erano state ambedue alla Corte francese, che
per le giovani fanciulle della nobiltà era una specie di lupanare di lusso,
atto a svezzarle.
Nella
descrizione di p. Pollini, Anna era di
alta statura, dai capelli neri, dal viso molto lungo, di colore pallido come se avesse patito spargimento di fiele;
nella gengiva superiore aveva un sopradente e nella mano destra, che copriva,
aveva un sesto dito; sotto il mento
aveva un gonfiore di carne (gozzo, ma per altri lo aveva tra le due mammelle
che sembrava ne avesse tre!), onde per ricoprire la deformità soleva coprire il
collo e il petto, così seguita nella moda degli abiti, dalle altre dame di
palazzo.
“Per il resto appariva affatto bella e
specialmente leggiadra nelle labbra, gentile nelle facezie e grazia nel ballare
e giocare; i vestiti che ogni giorno cambiava, erano bellissimi
e fu sempre singolare e per tutti i cortigiani, esempio e specchio.
Ma per quella parte che appartiene alle
aspirazioni, fu piena di ambizione, invidia e disonestà e fin da quando era
fanciulla di quindici anni, per cominciare a dare buon saggio di sé, si
accoppiò con il coppiere Thomas Boleyn e con il suo
cappellano. Fu poi mandata alla Corte francese - prosegue p.
Pollini -
dove viveva tanto poco onestamente che era chiamata “acchinea”,
cavalla inglese ed essendo venuta in gran dimestichezza e familiarità con il re
(Francesco I) era chiamata la mula del re
e pur essendo macchiata dell’eresia luterana, seguiva l’usanza di quella Corte
di andare a messa e seguire l’usanza del
re cattolico”.
Tornata in
Inghilterra era entrata nella famiglia del re (come damigella di Caterina) “rendendosi avveduta e astuta, avendole il re
fatto mostra delle fiamme che per lei portava nel petto. ed essendosi accorta
di quanto egli agevolmente mutasse capriccio con le altre concubine e
ricordando come erano miseramente cadute dalla grazia e favore, prima sua madre
e poi sua sorella, cominciò a non prestare orecchio alle lusinghevoli parole e
combattimenti amorosi del re, se egli
non l’avesse presa in moglie. E quanto più il re la combatteva, tanto
più lei faceva resistenza, santamente giurando che nessuno avrebbe avuto il
fiore della sua verginità, se non a colui che le fosse stato marito sommamente
fingendo, giacendo seco, di esporre il suo corpo al peccato. Con queste arti - proseguiva
p. Pollini - Anna immischiava l’animo e
il cuore del re che di lei, ogni giorno, più che mai invaghito, ripudiava
Caterina, per prendere una vergine, così buona e così santa, come era Anna
Bolena”.
Non vorrei,
scrive p. Pollini, che i lettori più
prudenti mi biasimassero, parendo loro che in questa storia io racconti alcune
cose che per essere minime e vilissime di qualità, rispetto alla qualità della
storia, sarebbe stato meglio tacerle, perché a me è parso non doverle tacere,
non solamente perchè sono state scritte dal grande
Nicolò Sandero, ma perché seguendo la verità della storia, queste minuzie mi
servono per manifestare quanto sia cieca la passione dell’amore poco onesto,
che ebbe la forza di far traboccare Enrico che, potentissimo e giudiziosissimo principe, macchiava la fama e l’onore
proprio con la perpetua rovina di quel reame (come si vede p. Pollini è
altrettanto generoso con il re! ndr.).
Così pensava
p. Pollini, ma per noi che li leggiamo a distanza di secoli, quegli avvenimenti
se accaduti, sono da considerare superati, che non avevano avuto grandi
conseguenze sugli sviluppi del regno, sia con Enrico VIII, sia con Elisabetta
che vedremo brillare di luce propria.
D. Hume (op.cit.) ritiene al contrario, che Anna Bolena fosse “di costumi innocenti, anzi virtuosi ma un
certo non so che di gaio e leggero nel contegno, la metteva fuor di guardia e
la rendeva meno circospetta sui doveri della sua situazione e la sua educazione
francese la portava a non osservare la rigida etichetta inglese”.
Ritornando
a fonti meno ardenti, l’abate Raynal scriveva (Histoire du divorce de Henri VIII et Cathrine d’Aragon, Paris, 1763) che “Anna
anche se non bella, era piccante, sprizzava fascino, il suo insieme sorpassava
la stessa bellezza, una taglia perfetta,
il gusto per la danza, una voce toccante e il talento per suonare
diversi strumenti, rivelavano l’esplodere della sua prima giovinezza; aveva
appreso delle maniere, un tono, dei modi che avevaano
fatto fissare su di lei l’ammirazione della Corte di Londra”.
Il
primo ad essere colpito dal suo fascino, era stato Henry (per altri, Thomas) Percy
figlio del conte di Northumberland, della prima nobiltà,
col quale era fidanzata; sebbene nipote del duca di Norfolk, non poteva
competere con Percy che alla morte del padre sarebbe divenuto il sesto o
settimo conte di Northumberland, a lei superiore per
ricchezza e nobiltà (cit. Raynal) .
In
ogni caso Percy, pur nella consapevolezza dei desideri del re, insisteva
nell’intenzione di sposare Anna, nonostante il padre gli avesse fatto rilevare
a quali pericoli si esponesse, se
continuava ad inistere nel disegno di sposare Anna
Bolena e trattandolo da folle e insensato, gli rimproverava la sua cattiva
condotta e inutilmente lo aveva
minacciato di diseredarlo. Alla fine Percy si sottometteva, lasciando libera Anna Bolena e sposando poco
tempo dopo, la figlia del conte Giorgio di Shrewsbury,
che moriva (1526) dopo il matrimonio della figlia con Percy.
Nel
frattempo Enrico, dopo aver nominato Anna Bolena, marchesa di Pembroke
(settembre 1532), nel mese di novembre faceva chiamare un prete di nome Orlando
Lec (che sarà nominato vescovo di Coventry) e faceva
celebrare le nozze seguendo il rito cattolico, in una cappella di Withe-Hall; alla cerimonia erano presenti Thomas Cranmer (di recente nominato da Enrico arcivescovo di
Canterbury, per la morte dell’arcivescovo William Warham) e il duca di Norfolk,
zio di Anna che rimase incinta poco dopo il matrimonio, dando prova di aver
ceduto anzitempo alle voglie del re.
Enrico,
resosi conto che la gravidanza progrediva ritenne fosse giunto il momento di
rendere pubblico il matrimonio (1533) e
fece emettere una sentenza che invalidava il matrimonio con Caterina e dopo che
Anna era stata, con grande sfarzo, incoronata regina (1533); nel mese di
settembre nasceva Elisabetta che, per la gioia del re ebbe anch’essa il titolo
di principessa del Galles; ciò era avvenuto prima che fosse dichiarato nullo il
matrimonio con Caterina (che morirà nel gennaio del 1535).
Elisabetta
(1533-1603) era l’unica sana, nata da questa unione, su tre aborti dovuti a tare portate dal patrimonio genetico dei
Tudor, che due ricercatrici hanno individuato nella sindrome degenerativa di McLeod, che si
era sviluppata a quarant’anni (vale a dire dal 1531) e aveva comportato il
deterioramento fisico e psichico di Enrico; ma, a nostro parere i due mali che
lo affliggevano già da prima erano, più
banalmente, la sifilide e il diabete.
*) Il
Campo del Drappo d’oro era stato il grande avvenimento del 1520 in cui Entico VIII ncontrava Francesco I
(1520) tra Guines e Ardres,
nella più inusitata magnifocenza, ciacuno con il
proprio seguito, fissato nel numero di cinquemila partecipanti; i nobili che vi
parteciparono si ingolfarono di debiti, di cui molti non se ne liberarono per
tutta la vita; il duca di Backingham (discendente in
linea femminile dal duca di Glaucester, figlio di
Edoardo III, primeggiava per lignaggio e
ricchezza; pur essendo ricco, era economo e nel vedere a quale ingente spesa
giunsero gli allestimenti, uscì in parole disgustose nei confronti di Walsey, ritenendolo l’autore della spesa; questa imprudenza
non fu dimenticata. Infatuato di astrologia giudiziaria, un frate certosino di
nome Hopkins lo convinse che un giorno sarebbe salito sul trono d’Inghilterra.
Era giunto a minacciare la vita del re; fu tratto in giudizio e il duca di
Norfolk il cui figlio, conte di Surrey aveva sposato la
figlia di Buckingam, fu creato lord maggiore per eseguire
la sentenza; Edward Stafford, duca di Buckingam, condannato a morte, non venne graziato dal re,
come si riteneva, per la vendetta covata da Wolsey; il suo palazzo fu destinato
ad abitazione reale.
EMERGE
THOMAS
CROMWELL
FINITO
SUL ROGO
LA
CONDANNA
PER
ANNA BOLENA
E’
MUTATA
IN
DECAPITAZIONE
|
I |
n
questo periodo sale la scala degli onori alla maniera di Wolsey, l’ambizioso
Thomas Cromwell, nemico del clero cattolico, entrato
nelle simpatie di Anna e per i consigli dati ad Enrico, nominato Tesoriere, Cancelliere
del regno e Vicario generale o vicereggente, nuova carica che gli assegnava il
potere assoluto sulla Chiesa.
Il
suo matrimonio lo aveva fatto scacciare dalla
Università di Cambridge dove insegnava ed era stato il primo a scivere un libro sul
divorzio del re (1530) più ardito di ogni altro teologo, che gli procurò la
celebrità e le simpatie del re.
Alla
morte dell’arcivescovo Warham (1532) fu eletto arcivescovo di Canterbury, vale
a dire primate d’Inghilterra, ma la bolla di nomina del papa giungeva l’anno
successivo (1533), con il suo giuramento di fedeltà al papa, che non si poteva
conciliare né con la sua dottrina (era di animo luterano scrive Raynal in cit, Divorce), né con
la sua condotta: pubblicamente era il ministro delle passioni di Enrico;
infatti dichiarava nullo il matrimonio di Enrico e Caterina, le cui conseguenze
abbiamo già esaminato. Cromwell instaurò una politica
inquisitoria nei confronti dei monasteri che faceva ispezionare dai suoi
commissari; il suo primo provvedimento fu di congedare i frati e le
monache che non avessero compiuto i
ventiquattro anni. Poi fu la volta del
provvedimento del Parlamento che sopprimeva i monasteri con un reddito sotto le
duecento sterline, che erano i monasteri più licenziosi; ma in tutto ne furono
aboliti seicentoquarantacinque, oltre agli arredi e argenteria per centomila
sterline; con la conseguenza che furono immessi sulle strade diecimila
accattoni.
Anche
la stella di Cromwell, nominato conte di Essex e insignito dell’ Ordine della Giarrettiera, fino ad
allora assegnata a personaggi di alto lignaggio, doveva tramomtare
a causa della sua avidità. Odiato dai nobili per aver accumulato una infinità
di cariche, dai catttolici come nemico della loro
religione e dai protestanti perché concorreva nelle persecuzioni contro di loro,
anche il re se ne voleva disfare perché riteneva che gli aveva fatto perdere l’amore
dei sudditi.
E’
il periodo, come vederemo, dell’amore di Enrico per
Caterina Howard, nipote, del duca di Norfolk, che odiava Cromwell
e lo fece arrestare senza processo, con la sola dichiarazione della Camera dei
Pari che lo accusava di eresia e delitto contro lo Stato e con l’approvazione
della Camera dei Comuni; inutile era stata una accorata lettera che aveva
scritto a Enrico dalla Torre: Cromwell fu arso vivo.
Anna aveva
avuto un altro aborto ed Enrico smaniava per avere un figlio maschio; a Greenwich dove si
trovava la Corte, si stava svolgendo un torneo ed Enrico aveva visto Anna che da
una finestra aveva lasciato cadere un
fazzoletto per un favorito che stava passando in quel momento, perché si
asciugasse il sudore del viso,
Enrico prestava
orecchio alle voci maligne della viscontessa di Rocheford
(che gli faceva da mezzana per gli amori clandestini), moglie di Giorgio Boleyn, visconte di Rocheford,
fratello di Anna, la quale nutriva un
vero odio per la cognata e tacciava suo
marito di avere una tresca con la sorella, mentre Enrico Norris,
capo del Guardaroba, Weston e Brereton,
gentiluomini di camera e Marco Smenton sovrintendente
di camera, godevano le grazie della regina e la servivano forse con troppo zelo,
da dar luogo ai pettegolezzi.
La gelosia di
Enrico non derivava dall’affetto, ma dall’orgoglio ed era dovuta alla
circostanza che aveva già messo gli occhi su una giovane damigella del seguito
di Anna (che Anna aveva potuto vedere un giorno mentre la teneva sulle sue
ginocchia), di singolare bellezza; costei era
Jean Seymur, figlia di sir John Seymur e le intenzioni che frullavano
nella mente di Enrico, nei confronti di Anna, non erano delle migliori.
Egli, per
la scena del fazzoletto, in preda alla gelosia, abbandonò Greenwich
e se ne tornò a Londra mentre Anna ricevette l’ordine di rimanere nella sua
stanza, mentre Norris, Weston,
Brereton, Smenton e il
fratello Giorgio furano arrestati; il giorno seguente Anna fu prelevata per
essere portata alla Torre di Londra ed ebbe una crisi isterica in quanto non riuscivaa a spiegarsi il motivo di ciò che stava accadendo.
Norris, Weston,
Brereton, Smenton dopo
essere stati suppliziati, furono condannati per condotta criminosa con la
regina; Anna e il fratello Giorgio furono condannati da un collegio di giurati composto dal duca di Sussex, marchese di Exeter, conte di Arundel
e duca di Norfolk, zio di Anna (mentre padre Pollini aggiunge anche Thomas Bolen che, per quanto abbiamo detto, non si considerava
padre di Anna), per incesto; Anna era condannata a essere bruciata o decapitata a scelta del re, il quale la
graziò concedendole la decapitazione (maggio 1536); inutile fu una sua acccorata e pietosa lettera al re che aveva già maturato l’intenzione
di sostituirla con il suo nuovo gioiello.
Non pago
della condanna, Enrico volle far dichiararre nullo il
matrimonio con Anna, non rendendosi conto che con la nullità del matrimonio venivano
a cadere tutte le accuse di incesto e infedeltà che a lei si erano volute addebitare;
decise anche di dichiarare illegittima la prole
dei due matrimoni con pene per chi avesse asserito il contrario; mentre il
Parlamento, ligio ai suoi voleri, ratificava tutte le sue decisioni.
NUOVO
MATRIMONIO
DI ENRICO CON
JEANE SEYMUR
RIFORMA DEL
CULTO
E PERSECUZIONE
DEI
PARENTI E
AMICI
DEL CARDINAL
POLO
|
D |
opo aver sposato Jeane e annullato ogni riconoscimento di figli nati precedentemente
al matrimonio con la Seymur, Enrico riunì un Concilio (1536) per decidere la
forma del culto che si dovesse seguire e dando incarico a Cromwel,l
si decise che Pater noster
e Ave fossero recitati in lingua inglese
e fu scritto un libretto cattolico, in cui si ordinava ciò che si dovesse
credere ed osservare e per i cattolici conteneva sei punti essenziali sul Santissimo Sacramento,
con la transustantazione; questo sacramento si poteva
ricevere in una sola forma; rimaneva il celibato per i sacerdoti e l’osservanzaa della castità e vedovato; rimaneva la
celebrazione della messa e infinea si manteneva la
confessione segreta.
Inoltre nel
1539 fu emesso un bill (erano i decreti emessi dal re) con sei
articoli che imponeva l’osservanza di norme cattoliche, escludendo il
riconoscimento dell’autorità del papa. Si stabilì infine che chiunque discustesse di religione, fosse considerato eretico.
Inoltre, per
la tendenza di Cromwell verso il protestantesimo e
dopo averli combattuti, si fissavano principi comuni a luterani e zwigliani. Cromwell era
decapitato (1540) e nel 1543 era pubblicato il Libro del re; manteneva i sacramenti del battesimo, eucaristia e penitenza, sebbene
quest’ultima non fosse stata ordinata da Cristo; il nome del papa era
eliminato, sostituito dal suo (il nuovo
Papa Paolo III pubblicava la sentenza di scomunica e nullità del matrimonio
emessa da Clemente VII e non pubblicata) ed eliminato anche il purgatorio;
disponeva un nuovo ordine dei vescovi. Stabiliva che i minori dei ventiquattro
anni uscissero dai monasteri e tornassero al secolo; quelli che superavano tale
età potevano fare lo stesso. Infine spogliò gli altari e le chiese di tutte le reliquie,
ornamenti e cose pregiate.
I cattolici
in molte province del Nord presero le armi ed Enrico mandò i duchi di Norfolk e
Suffolk per sedare le rivolte; esse furono sedate con il giuramento, da parte
di Enrico che le disposizioni sarebbero state emendate e, una volta sedate le
rivolte, furono giustiziati per mano del boia (1537) duemilaottocento
cattolici, compresi nobili e abati.
Non fu
risparmiato il figlio del primo signore del regno, duca di Norfolk, Thomas Howard, col
pretesto che avesse contratto parola di
matrimonio con Margherita Tudor, sorella di Enrico, il quale fu arrestato e poi
trovato morto avvelenato; in questo periodo moriva anche il figlio naturale di
Enrico ed Elisabeth Blount
(*), Henry Fitz-Roy, duca di Richmond e Somerset, morto senza figli.
Jane Seymur,
minata dalla consunzione, (1537) metteva al mondo il figlio Edoardo (1537-1553); il parto si
presentava difficile e ad Enrico fu chiesto se volesse che rimanesse in vita la
madre o il figlio; il re rispose di salvare il figlio, che di mogli ne avrebbe
agevolmente trovate; Jane morì e il figlio Edoardo fu salvo, ma era malaticcio
e, come vedremo, morì a sedici anni.
Il papa
Paolo III (1534-1549) con l’intento di trovare una pacificazione, nominava cardinale Reginald Polo (Poole
1500-1558), figlio della contessa di Salisbury, di stirpe regia, in quanto
figlia di Giorgio, duca di Clarence, fratello di Edoardo IV, il quale era a
studiare a Parigi quando il clero francese si era dichiarato contrario al
divorzio di Enrico VIII, ma lui con l’inviato del re si era mantenuto estraneo
alla diatriba.
Il re
voleva averlo nelle sue mani e aveva chiesto a Francesco I di mandarlo in
Inghilterra; Polo, recandosi a Cambrai aveva appreso
che in Inghilterra era stato dichiarato colpevole di lesa maestà e che sulla
sua testa era stata fissata una taglia di cinquantamila scudi.
Il papa,
informato, lo chiamò a Roma e gli assegnò delle guardie per salvaguardare la
sua sicurezza, nominandolo suo legato
nelle Fiandre. Enrico, irritato perché gli era sfuggito, sfogò la sua collera
contro i suoi parenti e amici e fece tagliare la testa (1541) alla madre che
era in età avanzata, alla marchesa Gertrude
d’Ex, ad Adrian Fortecu e
Thomas d’Ingley, cavaliere dell’Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme, a Henry Polo, signore di Montaigu
e a sir Goffredo, fratelli di Reginald, a Henry de Courtenay,
marchese d’Ex e conte di Devonshire (figlio di una figlia di Edoardo IV), a Eduard Nevil, della Casa
dei conti di Warwic e Salisbury e a due preti
(Sandero op. cit.); di tutti costoro, solo Goffredo della Poole
era stato graziato.
*) Era la seconda
esperienza amorosa di Enrico durante il matrimonio con Caterina; Elisabeth era presente
a una festa di Natale del 1514 nella quale Elisabeth aveva cantato e danzato e
il re le aveva donato una villa nella contea del Sussex
... e nel 1519 era nato Fritz-Roy, sei anni dopo fu creato
duca di Richmond; Elisabeth tra il 1522 e 1523 sposava uno dei principali
ufficiali di Wolsey, Gilbert Talboys al quale Enrico donava grandi somme di danaro e diversi
manieri nelle contee di Lincoln e York e nel 1524 Gilbert era nominato sceriffo
di Lincoln Shire. La prima esperienza, dopo nove anni di matrimonio con Caterina,
pare che Enrico l’avesse avuta con una delle due sorelle del duca di Bukingham (1510), che vivevano a Cort;
una era favorita della regina e l’altra amata da Enrico; da questo rapporto
sarebbe nato il risentimento tra il re e il duca che finirà decapitato
(1521).
ANNA DI CLEVES
E’ RIPUDIATA E
CATERINA
HOWARD
FINISCE SUL
PATIBOLO
|
E |
ra stato Cromwell ad aizzare Enrico contro Polo e perseguitare i
cattolici e poiché in Germania era morto il
cattolico duca di Gheldria e gli era succeduto il duca Gugliemo
di Cleves, capo dei principi protestanti, riuniti
contro l’imperatore nella Lega di Smalcalda, Cromwell, per fortificare l’alleanza col principe germanico,
aveva pensato al matrimonio tra Enrico e
la sorella del duca, Anna di Cleves.
Un ritratto
di Hans Holbein fece decidere Enrico al matrimonio e
Anna fu spedita in Inghilterra; Enrico era curioso di vederla, per accertarsi
che fosse rotonda nel fisico, in quanto lui era già in uno stato avanzato di pinguedine
(*).
Curioso di
vederla, si recò segretamente a Rochester e sebbene l’avesse trovata grande e pienotta come desiderava, gli parve
priva di bellezza (come in effetti
appare dai ritratti che vediamo noi, non di quelli mostrati al re! ndr.) e la giudicò una cavallaccia fiamminga; le cose peggiorarono
quando si accorse che Anna parlava l’olandese, che lui non conosceva e gli veniva
a mancare il piacere della conversazione che egli amava e lo avrebbe ripagato
della sua grossolana figura.
Tornato a Greenwich di malumore, i suoi consiglieri discussero sulla
possibilità di sciogliere il patto di matrimonio e rimandarla a casa. Ma per
una decisione del genere, parenti e amici della principessa si sarebbero
risentiti dell’affronto ed Enrico decise di affrontare il matrimonio, celebrato
fastosamente a Greenwich (1540); ma della povera Anna
ne era disgustato, abituato alla freschezza giovanile, per cui il matrimonio non
fu consumato; ma era aumentato il suo risentimento nei confronti di Cromwell, che come abbiamo visto, finiva sul patibolo.
Il
matrimonio fu discusso in Parlamento dove la Camera dei Pari e quella dei Comuni chiesero al re, con una
petizione, di lasciare che il Parlamento esaminasse per mezzo del Convocator (costituito
da una commissione di vescovi e abati), il suo matrimonio con Anna di Cleves; risultò che Anna era stata fidanzata con il duca Antonio
di Lorena, quando ambedue erano in minore età e il fidanzamento era stato
annullato per comune consenso.
Ciò
rappresentava motivo di divorzio, al quale (scrive D. Hume op. cit.), se
ne aggiunsero altri due, un pò strani: di non
aver dato l’interno assenso all’atto di nozze e di non aver ritenuto di
consumare il matrimonio. Il Convocator si mostrò soddisfatto e solennemente il
matrimonio fu dichiarato nullo e ratificato dal Parlamento che emise la
sentenza, che fu notificata alla prinipessa.
Questa principessa era dotata di grande apatia
e accettò l’offerta di Enrico di adottarla come sorella, di assegnarle il
seggio dopo la regina e la propria figlia, e di assegnarle un reddito vitalizio
di tremila sterline e, così soddisfatta, scrisse al fratello (il padre nel
frattempo era morto) che era stata ben trattata e che rimaneva in Inghilterra.
*) Alla
gamba destra di Enrico, si era aperta un’ulcera cancerosaa
(certamente diabetica) che emanava un odore fetido; poiché Enrico continuava a
mangiare e bere senza alcun limite, il suo ventre si era rilassato a tal punto
che a malapena riusciva a passare per le porte ed era trattenuto con un cerchio
di ferro; inoltre aveva una mano pressoché paralizzata e per questo era
divenuto irritabile e violento.
Al Metropolitan Museum di New York era
stata trovata un’armatura enorme che non si sapeva di chi fosse, poi si scoprì
che era di Enrico VIII, certamente indossata quando con l’’esercito era andato
ad assediare e prendere (1546) Boulogne, l’anno
precedente alla sua morte.
L’ULTIMO
MATRIMONIO
DI ENRICO CON
CATERINA PARR
E MORTE DEL RE
|
S |
istemata
così la faccenda con Anna di Cleves, l’amore di
Enrico si riversò su Caterina Howard bella e gentile, che con i suoi modi era
riuscita a cattivarsi il suo amore al punto che egli non ne faceva mistero, tanto da ringraziare
il cielo nella cappella di corte, sulla felicità del suo stato matrimoniale.
Ma il
diavolo si nasconde nei particolari: Caterina era per sua natura una dissoluta
e su questa sua debolezza non vi sono i dubbi in quanto sua sorella, addetta un
tempo al servizio della vecchia duchessa di Norfolk, aveva riferito particolari
della sua vita licenziosa con due giovani, al servizio della duchessa, Derham e
Mannoc, di cui lei non ne aveva fatto neanche tanto
mistero con il personale della duchessa.
Cranmer ne parlò con il conte di Hertford e con il cancelliere che decisero di riferire al
re e ritenne che più che riferire a voce, sarebbe stato più prudente scrivere
una relazione che fu consegnata al re. Enrico stentava a credere a ciò che
leggeva e disse che riteneva falsa tutta la relazione e Cranmer
sapeva bene che rischio stesse correndo, se non avesse fornito le prove.
Si dovette
ricorrere alla sorella di Lascelles, che risiedeva
nel Sussex. Sotto pretesto di una partita di caccia,
interrogata, lei fu costante nel riferire i particolari di ciò che sapeva e
catturati Mannoc e Derham, non solo confessarono ogni
cosa ma aggiunsero anche particolari che servivano maggiormente a disonorare la
regina. Tre cameriere della casa dei Norfolk erano a conoscenza del segreto di
Caterina, e una di queste aveva partecipato alcune notti, ai suoi incontri con
i due amanti. Riferite queste circostanze al re, egli, dopo essere rimasto
muto, proruppe in un pianto dirotto e rimase sorpreso che la sua abilità di
riconoscere una vergine, come si era vantato in precedenza, in questo caso fosse
fallita.
La regina
in un primo momento negò, poi ammise che i rapporti si erano verificati prima
del matrimonio, ma vi erano le prove del suo rapporto con Thomas Colepepper
dopo il matrimonio (che era un bel giovane, scrive padre Pollini, da cui
intendeva avere un figlio maschio da offrire a Enrico che non era più in buono
stato di salute, per soddifare le sue voglie di avere
un maschio!) e risultava che aveva ripreso al suo servizio Francis Derham, in
ricordo delle sarabande notturne in casa Norfolk.
Enrico, si
rivolse al Parlamento (1542), per avere una decisione; le due Camere emisero una sentenza per fellonia contro la
regina e la viscontessa di Rocheford e contro
Colepepper e Derham e con altra sentenza condannavano la duchessa di Norfolk,
ava di Caterina e lo zio di questa, Guglielmo Howard, con la moglie contessa Bridgewater e altre nove persone, colpevoli di aver tenuto
nascosta la cattiva condotta di Caterina; per la Norfolk e altri giunse il
perdono di Enrico, mentre lady Rocheford, che era
stata la causa principale del destino di Anna Bolena, fu decapitata con la
regina a Jowenville, “e la sua condanna, scrive Hume, servì
a confermare il pubblico, nella convinzione che aveva sempre nutrito per
quella infelice regina”.
Enrico
aveva fatto tradurre la Bibbia (il numero era limitato a cinquecento copie in
quanto non tutti sapevano leggere), concedendo a tutti il diritto di leggerla,
ma vi era stato un ripensamento, in quanto (1453) molte persone sediziose e
ignoranti avevano abusato del
permesso di leggerla e si erano
causate molte diversità di opinione, molte
animosità, tumulti e scismi e si era finito con l’invertire il senso delle
Scritture, per cui si consentiva di leggerla soltanto a gentiluomini e mercanti.
Nel mese di
luglio (1453) Enrico sposava la sesta moglie, Caterina Parr,
vedova di lord Nevil Latimer, donna virtuosa e colta,
con la quale egli conversava e l’argomento che amava affrontare era quello
religioso.
Su questo argomento la nuova regina propendeva
per la linea luterana, non gradita da Enrico, divenuto cruccioso
e iracondo e certamente il rapporto amoroso sarebbe stato interrotto da
un’altra esecuzione, se nel frattempo non fosse intervenuta la sua morte.
Enrico
prima di morire aveva convocato il
Parlamento e aveva fatto stendere una legge in base alla quale ristabiliva
l’ordine di successione con il principe di Galles, seguio dalle due
principesse, anche se, come al suo
solito, lasciava la strada di queste ingarbugliata, nel senso che non annullava
il precedente atto che le dichiarava illegittime.
Nessuno
osava parlare con il re delle sue condizioni fisiche, ma il baronetto Antony Denny prese
coraggio e lo esortò a prepararsi al destino che lo attendeva; Enrico
rassegnato chiese una tazza di vino bianco (*) e chiese di Cranmer;
giunto Cranmer, sebbene avesse conservato tutti i
sensi, già non parlava; Cranmer gli chiese di dargli
la prova che moriva nella fede di Cristo; Enrico gli strinse la mano ed esalava
l’ultimo respiro.
Enrico, tra
i suoi assassinii, legalizzati dalle sentenze, non aveva risparmiato neanche l’anziano
Thomas Howard duca di Norfolk (1474.1554), suo cognato, per essere marito della
sorella Maria, zio di due nipoti e suocero, in quanto suo figlio naturale, duca
di Richmond, aveva sposato una sua figlia; oltre ad essere stato la colonna
portante del suo regno, ora si trovava alla Torre per essere giustiziato; il
luogotenente venuto a conoscenza della morte del re, aveva differito
l’esecuzione, salvandolo da una ingiusta condanna.
*) A londra l’acqua era fetida conme
l’aria e si beveva vino dal primo mattino, e la colazione consisteva in un
pasto ed Enrico faceva colazione con un maialino arrosto di cui era ghiottto!
I PRIMI
SUCCESSORI
DI ENRICO VIII:
. EDOARDO VI
E JANE GREY
|
E |
nrico per
il piccolo Edoardo aveva destinato un Consiglio di sedici Tutori in gran parte cattolici, i quali miravano a ricostituire
l’unità della Chiesa; tra costoro vi era Eduard Seymur, conte di Ertford, fratello di Jean Seymur, zwigliano
di religione, che si era autonominato duca di Somerset
e verso il quale, alcuni Tutori per viltà. altri per paura, non osavano
contraddirlo, ad eccezione del cattolico Thomas Wrosley,
nominato Cancelliere da Enrico.
Seymur oltre
che Tutore di Edoardo, si era nominato per suo conto, Protettore
del regno, nomina convalidata da Edoardo, il quale gli confermava anche il
titolo ducale, con diritto a sedere alla destra del re sul trono. Edoardo inoltre,
nominava il Parr, fratello di Caterina, conte di Essex; il barone di Sudeley, marchese di Northempton;
John Dudley, conte di Warwich; Thomas Seymur,
fratello del Protettore, fu fatto barone di Sudeley e
Grande ammiraglio dell’armata di mare; Edward Seffeld
e Riccardo Riccio, baroni e cavalieri; il Cancelliere Thomas Wrosley fu nominato conte di Southampton, ma gli fu tolta
la carica di Cancelliere, assorbita dal Protettore, che in pratica esercitava
la carica di viceré.
Egli aveva
dichiarato che tutto ciò che riguardasse il governo del regno e della Chiese,
appartenessero a lui, mentre Cranmer. arcivescovo di
Canterbury, come primate, avrebbe agito in base a benestare di Edoardo.
La morte di
Enrico era stata tenuta segreta per alcuni giorni fino all’insediamento dei
tutori, dopodiché Edoardo era proclamato re d’Inghilterra e d’Ibernia; il suo breve regno di sette anni era stato carico
di avvenimenti, seppur non gestiti da lui personalmente, ma dai suoi tutori,
principalmente dal lord Protettore Seymur.
Edoardo
VI (1537-1553), salito al trono all’età
di dieci anni (1548), era un ragazzo intelligente e portato per gli studi;
conosceva il latino e francese, leggeva l’italiano e lo spagnolo, non ignorava
il greco e aveva buona conoscenza di filosofia, fisica e musica; aveva un
diario, che ci è pervenuto a testimonianza dei suo sentimenti interiori. Preso
dalla nuova religione, aveva proseguito la politica religiosa del padre, ma, la
sua cagionevole salute gli aveva consentito di regnare solo cinque anni, in
quanto moriva di consunzione.
Le sue doti
di intelletto avevano fatto ritenere che sarebbe stato un buon monarca, probabilmente
pizzocchero in quanto era zelante in teologia, con una certa tendenza alla
intolleranza.
Gli erano
stati assegnati due insegnanti di latino e greco, uno laico e l’altro prete
sposato, che gli parlavano continuamente di religione; lo stesso facevano le
principesse Anna di Cleves e Caterina Parr ed altre principesse, da rendergli odiosa la fede
cattolica.
Con Edoardo
il protestantesimo diventava la religione legale del regno; eras
punnlicato “Il libro di Edoardo” redatto da una commissione di vescovi esi definivano i seguenti punti; 1. il latino cessava di
essere impiegato per le preghiere, sostituito dalla lingua inglese e si adottava
una liturgia in inglese, tradotta in gran parte dalla liturgia cattolica. 2. Le
chiese erano spogliate di tutti gli ornamenti e si rapportavano al culto
cattolico; gli altari erano soppressi, i messali eliminati, tutte le insegne
sacerdotali erano ripudiate ad eccezione della cotta e un mucchio di pratiche
come l’uso dell’incenso, delle candele, dell’acqua benedetta, soppresse come
idolatriche. 3. Una condanna formale era sancita contro le dottrine del
Purgatorio, delle indulgenze, della venerazione e adorazione delle reliquie e
delle immagini, dell’invocazione dei santi; abolito il culto della Vergine, così popolare per i
cattolici. 4. I sette sacramenti dei cattolici erano ridotti al battesimo e all’eucaristia.
La cresima, l’ordine, il matrimonio erano conservati, ma solo come pratiche
edificanti. Quanto alla confessione auricolare, era lasciata alla discrezione
di ciascuno. L’estrema unzione era conservata, nel senso che si consentiva a
ciascun cristiano, al momento di comparire
davanti al giudice supremo, di intrattenersi con un ministro del
Signore. 5. Gli anglicani, conservando il sacramento dell’eucaristia, erano ben
lontani dall’intenderla come nella Chiesa romana. Secondo loro infatti, il corpo di Cristo era donato, preso
e consumato, in maniera spirituale e celeste ed essi negavano, nel termine più
positivo, la presenza reale. Secondo loro, i laici come i preti, dovevano, come
nella Chiesa primitiva, comunicarsi con le due specie. Quanto alla messa, essi
la consideravano come una invenzione blasfema, in quanto, non si può offrire
altro sacrificio per il peccato, se non quello offerto sulla croce. 6. La Fede era
sufficiente per ottenere la grazia per merito di Gesù Cristo e la Speranza,
come la Carità non erano indispensabili. 7. Il celibato ecclesiastico era
abolito, 8. La gerarchia extra-ecclesiastica era mantenuta, ma il re, sostituiva
il papa per decidere sul dogma, per fare amministrare i sacramenti, per
conferire la potenza spiritruale come lo stesso
pontefice romano.
Poiché in
quel periodo in Scozia moriva il re Giacomo V e gli succedeva la figlia Maria,
appena nata (1542), il Protettore aveva pensato
alla unificazione della Scozia all’Inghilterra, desiderata da dieci secoli,
facendo sposare con la forza Edoardo a Maria. Ma nei tormentati rapporti tra
inglesi e scozzesi, l’esercito inglese si scontrava con quello scozzese nella
battaglia di Pimki, pressso
Musselbourg, nelle vicinanze di Edimburgo
(10.9.1547), che si risolveva con una carneficina di scozzesi; e questo
disastro non fece che aumentare l’avversione degli scozzesi nei confronti degli
inglesi, che mandarono la piccola regina Maria in Francia (1548), per non farla
sposare a Edoardo.
Il
Protettore Edward Seymur aveva un fratello, Thomas Seymur, Ammiraglio di mare e
Capitano generale della milizia del re, che troveremo quando tratteremo della
giovanissima Elisabetta, il quale, con le donne, aveva facilità di approccio.
Alla morte di Enrico aveva sposato la sua vedova, Caterina
Parr, la quale a Corte entrava in competizione e in
discordia con la moglie del Protettore, sulle questioni di precedenza; la prima
come moglie del re defunto, la seconda, Ann Stanhope, come moglie del Lord Proettore;
ciascuna pretendeva la dignità della precedenza.
In questa
discordia avevano coinvolto i rispettivi mariti; in particolare, il Protettore
si lasciava dominare dalla moglie, della quale ne approfittava John Dudley,
conte di Warwich, il quale mirava alla rovina
dell’uno e dell’altro e coinvolgeva il predicatore Ugone
Latimer, il quale al tempo di Enrico era stato espulso dal vescovado di Worchester,
perché mangiava carne di venerdì.
Latimer come
predicatore, per il suo particolare linguaggio, i bei modi e le piacevolezze
che raccontava, era gradito al volgo che lo chiamava apostolo degli inglesi e nelle sue prediche accusava Thomas come
ribelle del re e traditore, che macchinava insidie e tranelli contro il re e meritasse di morire.
Intanto la
discordia tra le due mogli cresceva (ma prevaleva Caterina) e il Lord
Protettore che si lasciava governare dalla moglie, decise che il proprio fratello,
dovesse morire; ma a parte l’ambizione, non vi era un motivo valido per la sua
eliminazione, se non ricorrendo all’eresia.
Egli si
rivolse all’apostolo Latimer, convincendolo
a indicarlo nelle sue prediche come ribelle e traditore del re e del suo Protettore
e Thomas il 20 Marzo 1548 finì per essere arrestato, processato e condannato
alla decapitazione; mentre la moglie Caterina, che partoriva in quegli stessi
giorni, moriva di parto.
Alla fine
del regno di Edoardo le dottrine e il culto protestante erano completamente
stabiliti; nella capitale come nelle altre grandi città come nelle contee
prossime a Londra e che erano le più esposte alle innovazioni, la nuova fede
era adottata dalla maaggioranza delle classi
inferiori. Tuttavia il regno di Maria fece ancora di più per il protestantesimo
di Edoardo; l’inclinazione di Maria per il cattolicesimo servì a stimolare
l’energia dei predicatori protestanti. Uno di essi, John Knox, in un sermone
dato ad Amersham, nel Buckingamshire,
con grande partecipazione di pubblico, aveva fatto una violento discorso contro
la principessa Maria, avvertendo il pubblico del malessere che si sarebbe
verificato in Inghhilterra se questa principessa
fosse salita sul trono ciò che era stato detto anche di Jean Seymur durante il suo
corto regno (Galibert-Pellé, Angleterre
Paris, 1842).
E infatti
Maria, appena eletta, ristabiliva tutto quello che era stato annullato durante
il regno di suo fratello Edoardo e il
Parlamento (1553) con una sola legge, aboliva tutti gli atti che si riferivano
ai sacramenti che dovevano essere somministrati nelle due specie, all’elezione
dei vescovi, all’uniformità del culto, al matrimonio dei preti, all’abolizione
dei messali e delle immagini, all’osservanza delle domeniche e dei giorni di
feste, ordinando che il servizio divino fosse celebrato come nell’ultimo anno
del regno di Enrico VIII. Nello stesso tempo, i vescovi protestanti, respinti
dalla Camera dei lords, erano privati delle sedi
episcopali mentre Ridley e Cranmer inviati alla Torre finirono sul patibolo; Gardiner,
Tunstall Day e Heath erano ristabiliti nei loro vescovati.
Il ritorno
del cardinal Polo (1554), legato del papa, dava inizio alla reazione; il
parlamento ristabiliva gli antichi statuti contro l'eresia; ricostituiva tutto
ciò che era stato fatto contro la sede apostolica dopo il ventesimo anno di
regno di Enrico VIII e restituitti al clero tutti i
beni di cui erano stati spogliati sotto questo regno; infine, ebbero inizio le
terribili persecuzioni che insanguinarono il regno di Maria che
le valsero il lugubre epiteto di "Maria
la sanguinaria" ( cit. Galibert-Pellé) .
John Dudley,
duca di Northumberland, aveva incominciato ingordamente
a desiderare di impadronirsi del potere e concepiva l’idea di appropriarsi del
regno con il seguente ardito disegno: egli riteneva che gli inglesi, nonostante
il testamento di Enrico VIII, non avrebbero accettato come regine le due
principesse Maria ed Elisabetta, dichiarate bastarde e non avrebbero accettato
Maria Tudor e Maria Stuart perché cattoliche. Il duca di Suffolk, dalla moglie
Maria di Francia, aveva avuto due figlie, Frances,
che aveva sposato Henry Grey e Eleonor,
che aveva sposato Henry Clifford, conte di Cumberland.
Da Frances ed Henry Grey era nata
Jane, che Northumberland aveva concertato con il duca
di Suffolk di far sposare al suo quarto figlio Guilford
Dudley; egli inoltre, aveva ottenuto da Edoardo,
moribondo, nell’interesse del protestantesimo, di scartare dalla successione al
trono le due sorelle, in favore di Jane, che aveva la sua stessa età ed era
stata compagna della sua infanzia oltre ad essere zelante protestante e aveva
indotto i pari del regno a concedere l’assenso alla successione.
Jane (nata
nel 1537), aveva appena sedici anni e secondo un contemporaneo, anche se non bella, era carina, amabile
senza affettazione, dolce e modesta; aveva ricevuto un’ottima educazione
letteraria e l'amore che aveva per lo studio assorbivano quasi interamente tutto il suo
tempo e la lettura di Platone e del Nuovo Testamento in greco, e la conoscenza
del latino e delle lingue vive, testimoniavano il suo alto livello di
preparazione.
Jane nulla
sapeva del colpo di stato che le aveva preparato il nonno, duca di Northumberland e alla
notizia che egli le aveva dato, di essere stata eletta regina, era svenuta
dallo sgomento. Jane era restìa ad accettare, ma il
duca alla fine la convinse a prendere la corona e Northamberland e Suffolk la dichiaravano
regina (1553).
Northumberland aveva cercato di sorprendere a
Londra la principessa Maria per arrestarla, ma Maria avvertita era fuggita ed era
riparata presso la rocca di Framing nei pressi di Londra
con quarantamila volontari, accompagnata da Elisabetta e riusciva a sventare il
colpo di stato; Northumberland, processato, finiva
sul patibolo decapitato; Jane Gray arrestata, rinunziava
alla carica, ma era condannata a morte con il marito Guildford
Dudle; Jane, innocente, si era scusata e la regina
Maria, si era ben guardata dal concederle la grazia. Padre Pollini, nel suo
fanatismo cattolico, a questo proposito
aveva giustificato Maria, esprimendosi in questi termini: “regina clementissima e nemica dello
spargimento di sangue, molto più inchinevole all'amorevolezza che alla
vendetta, accettando le scuse di questa meschina signora (Jane), benignamente
la perdonò e per dovere di giustizia insieme ad alcuni dei suoi, le fece tagliare
la testa” (!).
Maria, come la vediamo
riprodotta nei dipinti, appare piuttosto rancorosa e vendicativa e non era stato
certamente il senso di giustizia ad aver fatto prevalere, per una
diciassettenne vittima della rapacità degli altri, la condanna a morte, ma piuttosto,
la sua fermezza nel non voler abiurare dalla nuova religione. Il cappellano della
regina infatti, le aveva chiesto di convertirsi, ma Jane era rimasta salda nella
sua fede e aveva rifiutato di abiurare.
L’aver
concesso il perdono e far eseguire la condanna da parte della regina, era un
chiaro sintomo di vendetta; per questi raptus
omicidi, determinati dal desiderio di voler estirpare l’eresia, Maria stava per
far perdere la vita anche a Elisabetta, salva solo per le insistenze del
primate Gardiner; non era un caso che Maria si fosse meritato il nome dù sanguinaria, dato
poi, ironicamente a un celebre coktail preparato con
succo di pomodoro.
MARIA I
LA SANGUINARIA
(BLOODY- MARY)
|
D |
opo
la parentesi di Jane Grey, salita al trono Maria I
Tudor (1516-1548), rinnovava il lusso e gli ori eliminati negli ultimi tempi da
Enrico e ricostituiva la moneta impoverita che suo padre aveva portato al
massimo della svalutazione, ingraziandosi, per quanto possibile, il favore
della plebe; Maria infatti, era stata l’unica tra tutti i Tudors,
compreso Enrico - che nonostante la sua ferocia il popolo non lo odiava - ad
essere odiata; per prima cosa, fece legittimare il matrimonio di sua madre
Caterina d’Aragona con Enrico VIII.
Maria non aveva
pregi per farsi stimare e amare e fisicamente non era avvenente; il suo viso come
appare da qualche suo ritratto, era cupo, freddo e austero e non lasciava
trasparire alcun segno di quella bontà che le attribuiva padre Pollini e ne parlava
come fosse una santa, scrivendo di lei “L'ottimo
e potentissimo Dio, dopo vent'anni dallo scisma concedeva mirabil
vittoria alla serenissima e cattolica principessa Maria, contro tutti i
principali baroni, cavalieri e principi di quel reame, senza spargimento di
sangue, volle con manifesto miracolo a tutto il mondo scoprire quanto le fosse
a cuore e quant'egli favoreggiasse la verità della fede e religione cattolica”.
Maria aveva
trentotto anni che all’epoca era già età avanzata per prendere marito e far
figli; si erano fatti i nomi del conte Courtenay di Dewonshire, proveniente dalla stirpe reale, il quale però
aveva inclinazione per Elisabetta, di cui preferiva la giovinezza e il gradevole conversare; da ciò derivò una
freddezza di Maria per Dewonshire e la velenosa animosità
nei confronti di Elisabetta.
Nel cuore
maligno di Maria, scrive Hume, vi era l’antica ruggine delle madri e dopo che
il Parlamento aveva ratificato (su sua richiesta) le nozze della madre, non le
mancava il pretesto per considerare la sorella, illegittima; pizzochera com’era (sotto le vesti portava il saio
francescano!), Hume la considerava, crudele, maligna, vendicativa, tiranna e
offendeva l’affezione che Elisabetta aveva per la religione riformata, che la
giovane principesa a stento celava e quando lei l’aveva minacciata di
conformarsi, Elisabetta aveva corso un grave pericolo per la sua vita.
L’altro
partito preso in considerazione per il suo matrimonio, era stato quello del cardinale
Reginald Polo, anch’egli, come abbiamo visto, di sangue reale, il quale però
era portato per una vita di studio (aveva scritto un testo sulla ”Unione della Chiesa” in quattro volumi
per Enrico); a risolvere la situazione interveniva Carlo V (v. Art. Carlo V ecc.) al quale un altro regno da
aggiungere ai suoi non sarebbe dispiaciuto, che proponeva il giovanissimo
figlio Filippo II (1527-1598).
Il loro matrimonio,
con disapprovazione generale, si era svolto a Westminster (1554) officiato da
Gardiner che anch’egli disapprovava; durante la cerimonia, in questo giorno che
per Maria era di trionfo, mentre il coro cantava il Te Deum, la sua esaltazione era giunta al
punto di sentire già nel suo grembo il sussulto di un erede, che avrebbe
consolidato il suo trono e poter trattare la protestante Elisabetta, come
Enrico aveva trattato Anna Bolena; ma per fortuna di Elisabetta, il destino
aveva disposto in maniera diversa.
Le
intenzioni di Maria erano, infatti, di togliere di mezzo Elisabetta, ma era
stato Filippo II a salvarle la vita, non
per un senso di pietà, di cui Filippo era assolutamente privo, ma per opportunità politica.
Disperando
di avere dei figli da Maria, Filippo si rendeva conto che tutti i cattolici ritenevano
che per diritto ereditario la corona d’Inghilterra spettasse a Maria Stuart,
regina di Scozia, nipote di Enrico VIII, in quanto figlia di Margherita, sua
sorella maggiore; fidanzata al delfino di Francia (che sarebbe stato Francesco
II) egli intravedeva la riunione sulla stessa testa di ben tre corone, quella
di Francia, di Scozia e d’Inghilterra.
Aveva
quindi pensato di unirsi a Elisabetta che, per questo motivo, era stata
condannata a una stretta cattività; ma ciò
le aveva salvato la vita, mentre assisteva alla esecuzione di Thomas Cranmer, che aveva servito fedelmente il padre e si era
rifiutato di abiurare e per vendetta Maria che per malignità lo aveva fatto
condannare per eresia (che comportava
il rogo) anziché per tradimento (che comportava il più umano taglio
della testa!).
Dopo quattordici
mesi dal matrimonio Filippo esasperato di vedere che la regina non procreava
figli, se ne partiva per le Fiandre (1555) nonostante i suoi pianti; egli neanche
rispondeva alle sue calde lettere, ma le scriveva soltanto per chiederle denaro
e lei si era spossata per accontentarlo e quando nello stesso periodo Carlo V
aveva abdicato in favore del figlio, lei
aveva perso ogni speranza di rivederlo.
Maria era
stata presa da malinconia ma si era ripresa quando Filippo volendo coinvolgerla
in una lega contro la Francia, tornava in Inghilterra e ottenuti diecimila
uomini, sotto il comando del conte Pembroke, avevano preso parte alla vittoria di Saint-Quentin.
Dopo questa
vittoria, Filippo non aveva accolto il suggerimento di lasciare una guarnogione spagnola a Calais, per custodirla, in quanto
minacciata dai francesi. Il duca di Guisa ne approfittava, riuscendo a impadronirsi
della città (1558), cara agli inglesi, che la possedevano da duecentodieci anni;
Maria non sopravvisse alla presa di Calais; colpita da idropisia (*), prima di morire
ripeteva che se fosse stato aperto il suo cuore, si sarebbe trovato scolpito il
nome di Calais.
Dopo sedici
ore dalla morte della regina, moriva anche il cardinal Reginald Polo a causa di
febbri intermittenti, che indicavano la malaria, che certamente aveva preso a
Roma, come tutti gli stranieri che si recavano in quella città, come abbiamo
detto in altri articoli. circondata di paludi, malattia che i romani non
prendevano in quanto naturalmente vaccinati.
*)
L’idropisia determinava un consistente rigonfiamento del ventre che faceva
pensare alla maternità.
IL RITORNO
ALLA
FEDE CATTOLICA
DURANTE IL
REGNO DI
MARIA RINFORZA
IL
PROTESTANTESIMO
|
C |
on l’insediamento
di Maria, il nuovo Parlamento aboliva con una sola legge tutti gli atti posti
in essere durante il regno di Edoardo, relativi: al sacramento che doveva
essere somministrato sotto le due specie; all’elezione dei vescovi;
all’uniformità del culto pubblico; al matrimonio dei preti; all’abolizione dei
messali e delle immagini; all’osservanza delle domeniche e dei giorni di festa,
ordinando che il servizio divino sarebbe
stato celebrato come nell’ultimo anno del regno di Enrico VIII.
Nello
stesso tempo i vescovi protestanti, respinti dalla Camera dei Lords, erano privati della sede episcopale; Ridley e Cranmer erano mandati alla Torre, mentre Gardiner, Bonnet,
Tunstall Day e Heath erano ristabiliti nei loro vescovati
Il ritorno
del cardinal Polo (1554), come legato del papa, dava impulso a una nuova reazione: il Parlamento ristabiliva gli
antichi statuti contro l'eresia; fu ricostituto tutto
ciò che era stato fatto contro la sede apostolica romana, dopo il ventesimo anno
del regno di Enrico VIII e furono restituti al clero
tutti i beni di cui erano stati sposgliati sotto
questo regno.
Nello
stesso tempo l’Inghilterra divenne teatro di orrore che rese i catolici oggetto di esecrazione e dimostrò che non vi è scelleraggine superiore alla vendetta e alla crudeltà
coperte dal manto della religione.
Ebbero
inizio le terribili persecuzioni che insanguinarono il regno di Maria e che le
valsero l’epitteto di Bloody-Mary; esse iniziarono con l’esecuzione
del prebendato di San Paolo, John Rogers, padre di
dieci figli, primo nella lista delle vittime, arso vivo a Smothfield;
aveva chiesto di vedere la moglie, ma Gardiner, aggiungendo la crudeltà
all’insulto, gli disse che non poteva avere una moglie.
Si
verificarono anche scene strazianti: l’esecuzione del vescovo di Glocester, Hooper,
fu eseguita a Glocester con l’intento di incutere spavento nel suo gregge; quando
era legato sul patibolo gli avevano messo davanti uno sgabello con sopra la
ritrattazione che gli avrebbe salvato la vita, ma egli lo fece rimuovere; il
forte vento impediva alle fascine verdi di prendere fuoco, per cui gli si
bruciarono le parti inferiori del corpo; una delle sue mani si era staccata e
con l’altra continuava a battersi il petto e pregare fino a quando gli si
gonfiò la lingua e non poté più parlare.
Sanders fu arso a Coventry e respinse l’
offerto perdono e sul patibolo diceva “salve
o croce di Cristo, eterna vita, salve”,
Così il
parroco di Hadley, Taylor, fu arso a Hadley e legato al
patibolo recitava un salmo in inglese, una delle guardie lo colpì sulla
bocca e gli ordinò di parlare latino, un
altro, stizzito, lo colpiva con l’alabarda sulla testa, uccidendolo e mettendo
fine ai suoi tormenti. Tutte queste uccisioni di protestanti, in tre anni di
selvaggia barbarie ebbero luogo solo percché essi non
volevano riconoscere la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo (che
era anch’essa una barbarie ed era valsa da parte dell’Islam l’accusa di
cannibalismo) nel sacramento!
Il vescovo Ferrar,
di Saint-David, aveva fatto appello al cardinal Polo,
ma fu bruciato nella sua diocesi e
Latimer e Ridley ambedue celebri per dottrina, furono bruciati a Oxford.
Ridley. nato a Welmonsswick, aveva studiato a
Cambridge, Parigi e Lovanio e aveva ottenuto il vescovato di Rochester e di
Londra e i suoi celebri sermoni contro Maria ed Elisabetta avevano dato il
pretesto dell’arresto alla Torre e della sua fine. Latimer aveva amici potenti
a Corte come Cromwell e la stessa Anna Bolena, ai
tempi di Enrico, che ascoltava con piacere le sue invettive contro il papa, gli
concesse il vescovato di Worchester (1535), che poi con lo stesso Enrico
perdette e finì alla Torre. Edoardo gli concesse la libertà e lo assunse presso
la Corte come suo predicatore. Egli si scagliava con pari violenza contro i
vizi di tutte le classi e con la stessa violenza declamava contro gli abusi che
disonoravano la nuova chiesa, dipingendo nel modo più ripugnante e
burlesco le pratiche del vecchio culto.
La sua eloquenza era vigorosa e veemente, ma il suo linguaggio era caustico e
grossolano accompagnato da gesti abietti e grossolani; tuttavia tale da
soddisfare il gusto degli uditori. Aveva
commesso l’errore di abbandonare le discussioni teologiche per le politiche e sosteneva
che Dio avrebbe fatto bene a togliere di mezzo le due principesse Maria ed
Elisabetta in quanto, sposando degli stranieri, avrebbero messo in pericolo
l’esistenza della Chiesa riformata; la stessa imprudenza commise all’inizio del
regno di Maria, che lo fece arrestare
per sedizione e finì sul patibolo.
Le esecuzioni religiose (1555) furono settantuno, nell’anno
successivo ottantanove, e nel 1558, l’anno della morte di Maria, quaranta, in tutto
duecentotottantotto; un altro centinaio morirono nelle
prigioni; molti protestanti, prevedendo la tempesta. si salvarono espatriando
rifugiandosi a Francoforte, Strasburgo e Ginevra. Tra i principali personaggi
vi furonop Francis Knollys, che in seguito divenne
vice-ciambellano di Elisabetta; sir John Cheke, sir Anthoni Cook; Peynet, che fu
fatto vescovo di Worchester; Grindal, che dopo essere
stato vescovo di Londra e arcivescovo di York, fu nominato arcivescovo di Canterbury, Knox il grande riformatore
scozzese, Fox il martirologista e un gran numero di tanti altri.
Ma tutte le violenze non fecero che accrescere
lo zelo dei riformatori protestanti che Elisabetta aveva trovato in maniera
tanto pronunciata, da risolverla a favorire questa religione, sebbene essa già
propendesse per essa (cit. Galibert-Pellé).
FINE
